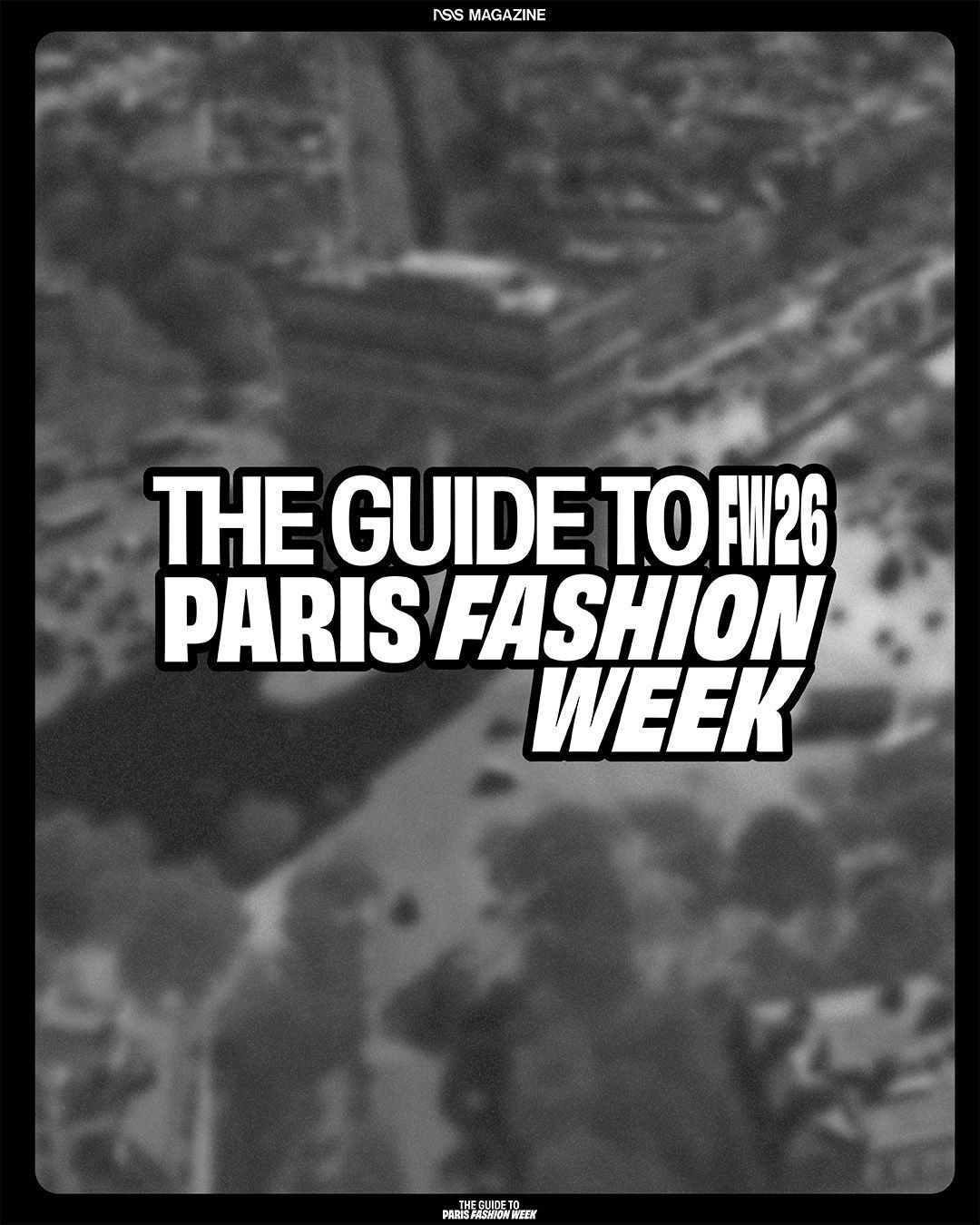Moda che non ha niente da dire Quando il paradosso della vendibilità lobotomizza i creativi
Dati alla mano possiamo asserire con certezza che a Parigi la Settimana della moda maschile da poco conclusa ha infranto ogni record. Grazie a momenti virali come il debutto della collezione di Pharrell per Louis Vuitton con tutto il battaglione di celeb a seguito, alla passerella ingegnosa di Dior con modelli che fuoriuscivano dal pavimento, all’ennesima iterazione virale di Wales Bonner con adidas, l'attenzione mediatica era alle stelle. Il tutto condito da star del K-Pop, musicisti e atleti nelle prime file, che hanno generato una visibilità dal valore EMV di 133 milioni di dollari. Ci si aspetterebbe pertanto che numeri sensazionali siano stati accompagnati da design altrettanto sensazionali, eppure non c’è un singolo abito che resti impresso, anche se del resto è difficile concentrarsi sui capi se sono Aron Piper e Vincent Cassel i modelli che li indossano. E dopotutto i milioni di utenti che attraverso i social media hanno seguito l’evento probabilmente non erano lì tanto per i capi quanto per lo show. Di certo in quell’ammasso di blazer ben tagliati ma anonimi, pantaloni sartoriali e camicie interscambiabili, in cui persino i design più particolari sapevano di déjà-vu, il consumatore (culturalmente medio ma economicamente alto spendente) non avrà problemi a scegliere.
Diversi mesi fa, al momento dell’insediamento di Pharrell Williams da Louis Vuitton, il New York Times aveva riesumato una vecchia intervista del musicista che si sarebbe rivelata profetica. «Sono un designer creativo dal punto di vista del consumatore. Non ho frequentato la Central Saint Martins. Ma sono sicuramente andato nei negozi e ho acquistato, e so cosa mi piace» aveva detto Williams in merito al suo approccio al nuovo ruolo di direttore creativo. E la sua collezione di debutto sarà di certo un successo con quel tripudio di monogram pop che già fa gola all’Asia finalmente libera dalle restrizioni Covid e un buzz mediatico globale da 1 miliardo di visualizzazioni. La rassegna parigina è stata la settimana della moda dei record, ma è stata anche e soprattutto la settimana della moda dei consumatori, con capi pensati in funzione del compratore finale (basti pensare alle nuove ballet shoes di Jacquemus già virali) e designer che hanno storicamente basato il proprio successo sulla ricerca di un’espressione che andasse oltre le leggi di mercato visibilmente stanchi (avevamo davvero bisogna dell’ennesima collaborazione Junya Watanabe x Carhartt? Quand’è che Marc Jacobs ha smesso di sorprenderci?) o spaventati di incappare in controversie come nel caso di Demna. Ritorna ciclicamente l’annosa questione: cosa ci aspettiamo dalla moda? Ma soprattutto, in una società in cui sono esistiti Martin Margiela, Alexander McQueen, Vivienne Westwood, la moda ha ancora qualcosa da dire?
In un’intervista del The Guardian che affrontava il noto ritornello - se la moda debba essere considerata come una forma d’arte o meno - la designer e direttrice del Design Museum Zandra Rhodes affermava che «La moda può raccontare come si vestivano le persone in un certo periodo, così come la ceramica può raccontare come erano i loro tea party. Non credo che il fatto che questi oggetti siano stati progettati per essere pratici li distingua dalle belle arti. Si potrebbe dire che un quadro è stato progettato per essere appeso al muro, ma se fosse stato realizzato come affresco, in cui faceva parte del muro, si sarebbe detto che non era arte perché era pratico?». Non è dunque l’utilità a sminuire un capo nella sua accezione artistica, quanto piuttosto la sua adesione ai criteri di vendibilità.
Incontrando alcuni designer emergenti in quelle fortezze elitarie che sono le scuole di moda, quelle che la storia (oltre che Pharrell Williams) hanno dimostrato non necessarie per lavorare nella moda ma che facilitano di certo l'accesso ad un settore altrimenti chiuso e respingente, si ha l'opportunità di verificare che le storie da raccontare non mancano quando la vendibilità non è ancora nella periferica di un creativo. I variopinti abiti di Rachel Tayza al Graduation Show del Polimoda incorporavano guanti in lattice per rivisitare il tropo del classico camice medico, un modo per esorcizzare la sua cagionevole infanzia in ospedale. Francesco Saverio Matera e Alessio Baldasseroni, studenti IED, scommettono su una proposta (già pronta a diventare brand) che si adatta alle esigenze corporali di tutti, anche di chi è portatore di disabilità, con outfit dall'estetica genderless e funzionale: «la nostra proposta di valore è per una moda esistenzialista, adattiva, un prodotto figlio di un ripensamento della dimensione umana nelle sue connessioni con la spazialità e la corporalità.» Al di là del fatto che la moda possa essere considerata arte o meno, sicuramente ciò che la distingue dall'abbigliamento è l’intenzione comunicativa, l’immaginario in cui si colloca e la storia che il designer che ne è l’artefice ci vuole raccontare. Forse il problema di questa generale stanchezza creativa deriva dal fatto che chi ha qualcosa da dire non ha i mezzi e lo spazio per dirlo, mentre chi ha i mezzi non ha, o non ha più, niente da dire. Sarebbe utopico augurarsi il contrario?