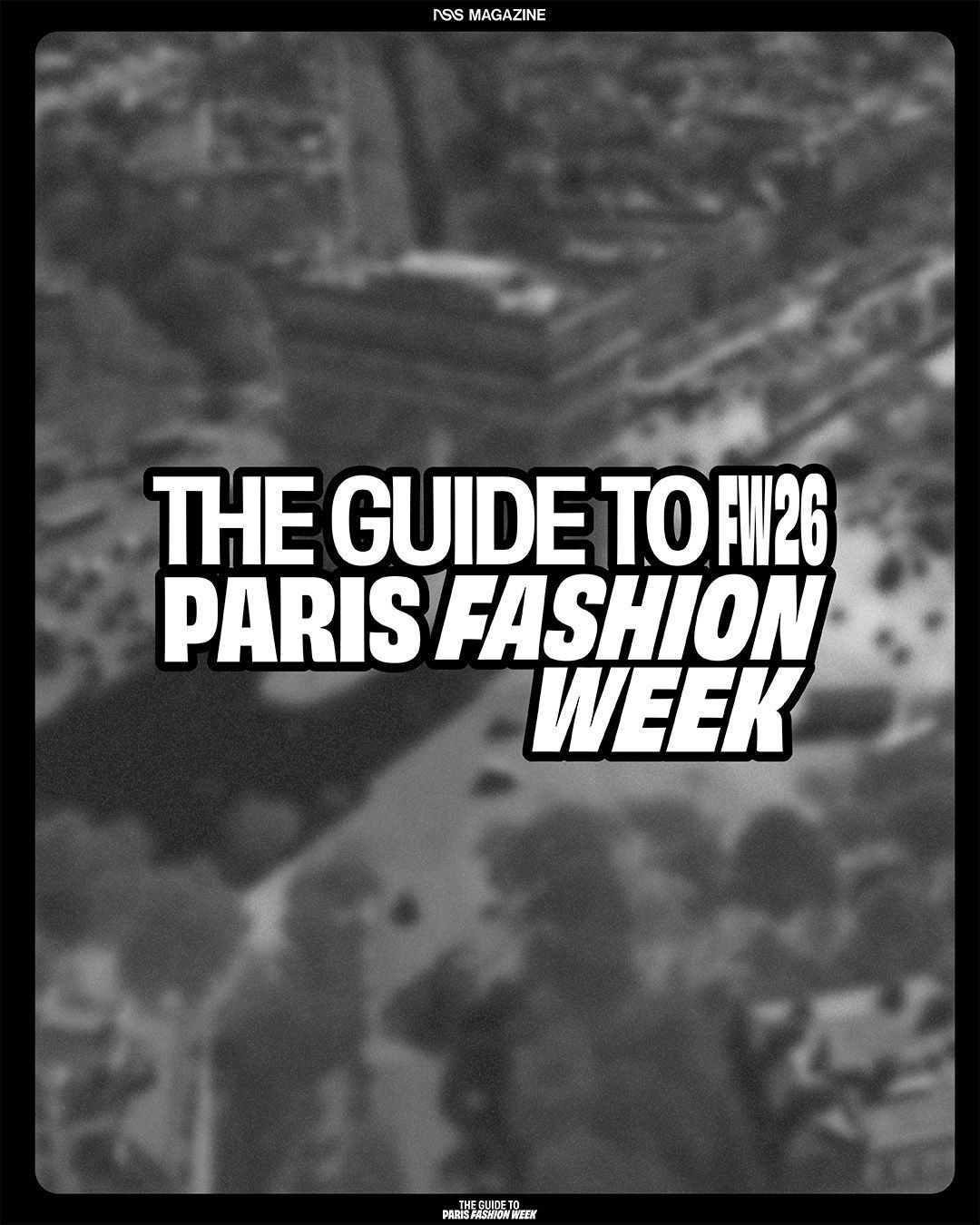La rivoluzione comincia dal tuo armadio La moda sostenibile secondo Marina Spadafora
«Bisogna essere vocal a riguardo», dice Marina Spadafora parlando della sostenibilità nella moda. E sarebbe difficile essere più vocal della designer che ha scritto e presentato, insieme alla giornalista Luisa Ciuni, il suo nuovo libro, La rivoluzione comincia dal tuo armadio, che esamina la spinosa questione dell'inquinamento causato dal fashion luxury. Le tesi di Marina Spadafora sull’argomento della sostenibilità sociale e ambientale della moda sono tanto cristalline quanto inoppugnabili: il pubblico deve farsi sentire con la forza di un grass-root movement, ossia un movimento che parte dal basso, finché chi decide non potrà più ignorare la questione.
I consumatori non conoscono infatti l’enorme potere che possiedono e, se smettessero di acquistare dai brand che ignorano l’etica sociale e ambientale, la loro influenza combinata potrebbe sbilanciare un equilibrio artificiale che esiste a discapito della natura e dei paesi a economia emergente. «Lotta dura senza paura», la definisce lei con ironia, tanto più che la designer e attivista condisce la sua filosofia di one-liners e battute che la rendono decisamente accattivante – e che sono stati trasposti nel libro presentato mercoledì scorso a Milano, sulla terrazza della Fondazione Sozzani, con un intervento di apertura del giornalista Alan Friedman.
nss magazine ha raggiunto Marina Spadafora poco prima dell’evento per farsi raccontare meglio la sua visione di una moda sostenibile.
Quello della moda sostenibile è un topic che domina il discorso interno all’industria della moda. In che modo e per quale motivo questo argomento ha catturato il suo interesse?
Io sono stata nel campo della moda in-sostenibile per tanti anni. Ho avuto il mio brand, ho collaborato con Ferragamo, Prada, Miu Miu, Marni e tanti altri. A un certo punto, verso il 2007, ho avuto un desiderio molto forte di dedicarmi a qualcosa che migliorasse le condizioni di chi lavora nella moda e del pianeta. È una cosa che viene da lontano: anche quando facevo le mie sfilate, erano eventi più ridotti, come quelli degli atelier, e quello che risparmiavo lo dedicavo ogni stagione a un’associazione benefica diversa. Dal 2007 fino al 2013 ho dedicato il mio lavoro alla sostenibilità in pieno. Sono stata direttore creativo di Altro Mercato, che ha 300 negozi in Italia, tutti dedicati al commercio equo e sostenibile. Per molti anni ho lavorato con artigiani in giro per il mondo: visitavo il Nepal, l’Etiopia, il Perù. È stato un periodo bellissimo.
Una moda pienamente etica è possibile?
Non solo è possibile, ma è necessaria. Io sono il coordinatore nazionale di Fashion Revolution, un movimento nato dopo il crollo del Rana Plaza in Bangladesh – un crollo nel 2013 in cui sono morte più di mille persone. Carry Somers e Orsola De Castro, a Londra, iniziarono questo movimento per rendere i consumatori più consapevoli del potere che hanno i loro soldi. Ogni volta che spendiamo, votiamo per il mondo che vogliamo. Se si compra nelle catene di fast fashion, si finanzia un’operazione che non è etica, si diventa complici. I marchi di fast fashion si stanno mettendo a posto dal punto di vista della sostenibilità, hanno firmato vari accordi, come il Detox Protocol di Green Peace, ma dal punto di vista sociale continuano a non pagare il giusto. Comprare fast fashion significa sposare quel modo di fare business, che è un modo di fare business che non rispetta le persone e neppure l’ambiente. Prima di fare un acquisto bisognerebbe informarsi. Esiste un’app di nome Good on You che assegna a ogni brand un rating sulla scala della sostenibilità sia sociale che ambientale. Inoltre bisognerebbe acquistare meno spesso ma qualcosa di più durevole. Curare i propri abiti e non buttarli – che è la cosa peggiore da fare. Il capo di abbigliamento più sostenibile è quello che è già appeso nel nostro armadio.
Gli sforzi dei brand in questo senso sono ormai altamente pubblicizzati. In quanti casi sono concreti e in quanti si tratta solo di green-washing?
Il problema del greenwashing esiste. Ma dipende da brand a brand. Il gruppo Kering è quello che fin dall’inizio è quello che ha enfatizzato la sostenibilità. Ma il vero, gigantesco problema è che non ci sono leggi a riguardo. Nel mondo del cibo e della cosmesi esistono regole molto chiare anche per come scrivere un’etichetta – per evitare cause legali. Nell’abbigliamento queste leggi non ci sono ancora. Fashion Revolution, insieme ad altre 60 associazioni, ha stilato una shadow policy sottoposta al Parlamento Europeo, di nome Fair & Sustainable Textile. Sapremo se i brand dicono o meno la verità quando esisteranno delle leggi che potranno controllare la veridicità dei loro statement.
Se la moda fosse del tutto sostenibile, i price point degli abiti salirebbero o scenderebbero? Credete che una moda sostenibile sia anche più economicamente sostenibile per i consumatori?
Io ho una teoria: a mio avviso se un brand inizia a fare le cose come dovrebbero essere fatte, è chiaro che il costo dell’abbigliamento si alzi. Ma il fatto che il brand si metta in regola non deve fare alzare il prezzo dei consumatori. Se un brand spende di più, deve rivedere leggermente i suoi margini di profitto. Se si pensa che il proprietario di Inditex è uno degli uomini più ricchi del mondo, ridurre di poco i suoi profitti cosa cambierebbe? Il sovraprezzo di fare moda in maniera corretta deve essere assorbito, secondo me non in toto, ma almeno all’80% dalla corporation. Non deve cadere tutto sulle spalle dei consumatori.
Il mercato secondario del lusso, il vintage e l’upcycling sono risposte adeguate al problema degli sprechi?
Io vesto solo vintage, forget about it. Ogni capo salvato dalla discarica o non mandato in Africa a intasare le loro discariche (tutto quello che mettiamo nei cassonetti finisce là poi) che viene rivenduto e riamato da qualcun altro è un grande successo. Si dà una seconda vita al capo. Il crimine peggiore è buttare via gli abiti – regalandoli, organizzando gli swap party si dà una seconda chance al proprio guardaroba.
Quindi i cassonetti gialli della raccolta abiti non servono?
Vengono fatte delle balle di abiti usati, che vengono spediti in paesi di economie emergenti. Ad Accra, in Ghana, c’è un mercato enorme in cui i mercanti comprano queste balle a scatola chiusa. Le aprono e metà di quegli abiti è danneggiata o sporca e loro la buttano. Le discariche e i fiumi di Accra sono del tutto intasati dai nostri abiti buttati via. Dobbiamo produrre di meno: produrre meno e meglio e che la gente lo faccia durare. È l’unico modo per andare avanti.
Nel cammino verso una sostenibilità nella moda, che parte gioca l’elemento digitale?
Dal punto di vista dell’informazione, il digitale ci dà la possibilità di condividere informazioni immediatamente. Il digitale non ha confini, non ha razza: fa sì che tu possa spaziare, il mondo è il tuo scrigno. Ma bisogna anche essere vocal a riguardo: se ognuno di noi diventasse una centrale di informazione, si crea massa critica. Nel momento in cui creiamo massa critica la bilancia si sposta e i governi non possono distogliere lo sguardo. Noi dobbiamo essere una forza dal basso, un grass-root movement, ma da sopra devono arrivare le leggi. E poi i brand non possono più scappare. I brand dal top devono motivare la loro catena. E se non gli interessa farlo dovranno, perché altrimenti noi non compreremo più i loro abiti. L’idea è quella del boicottaggio: lotta dura senza paura.