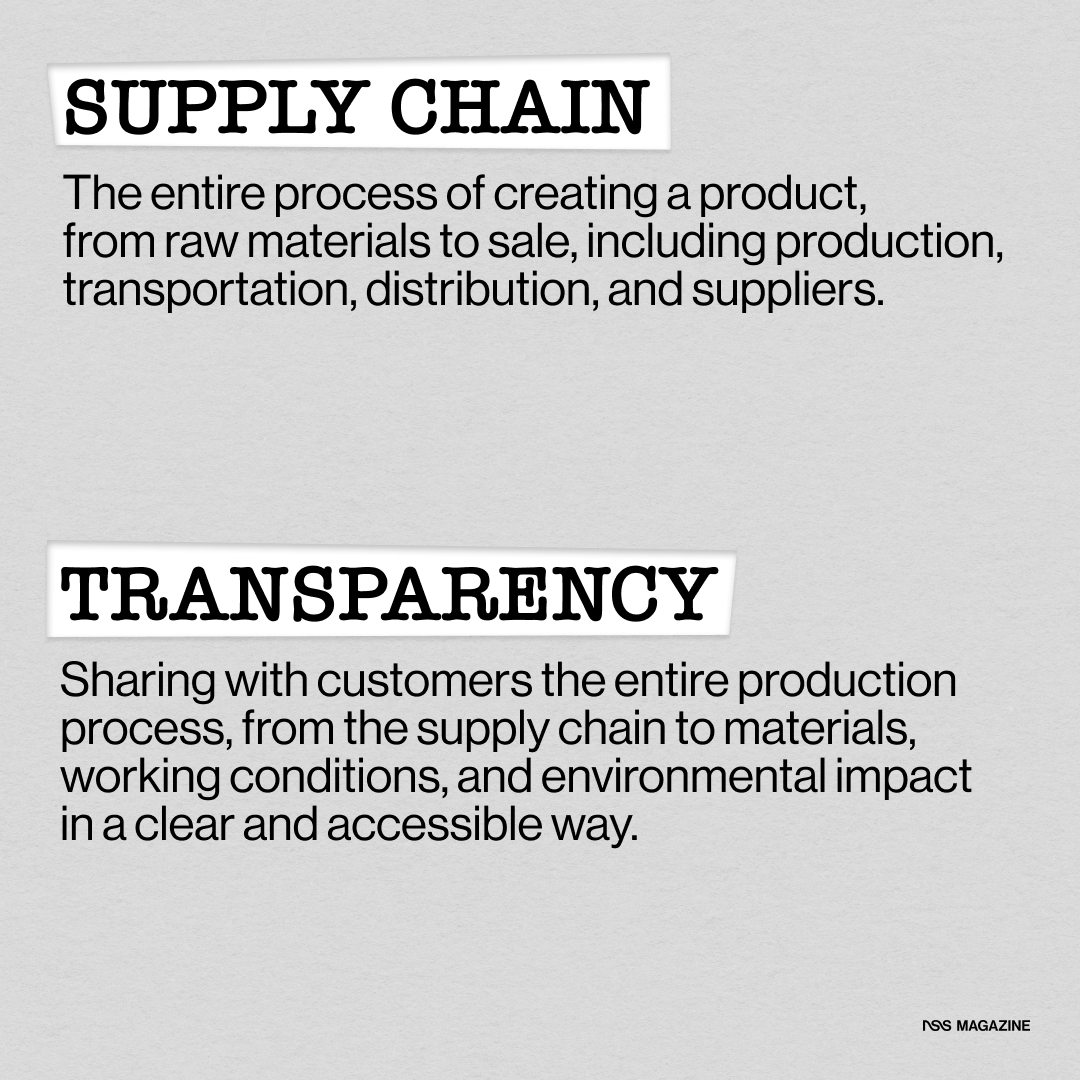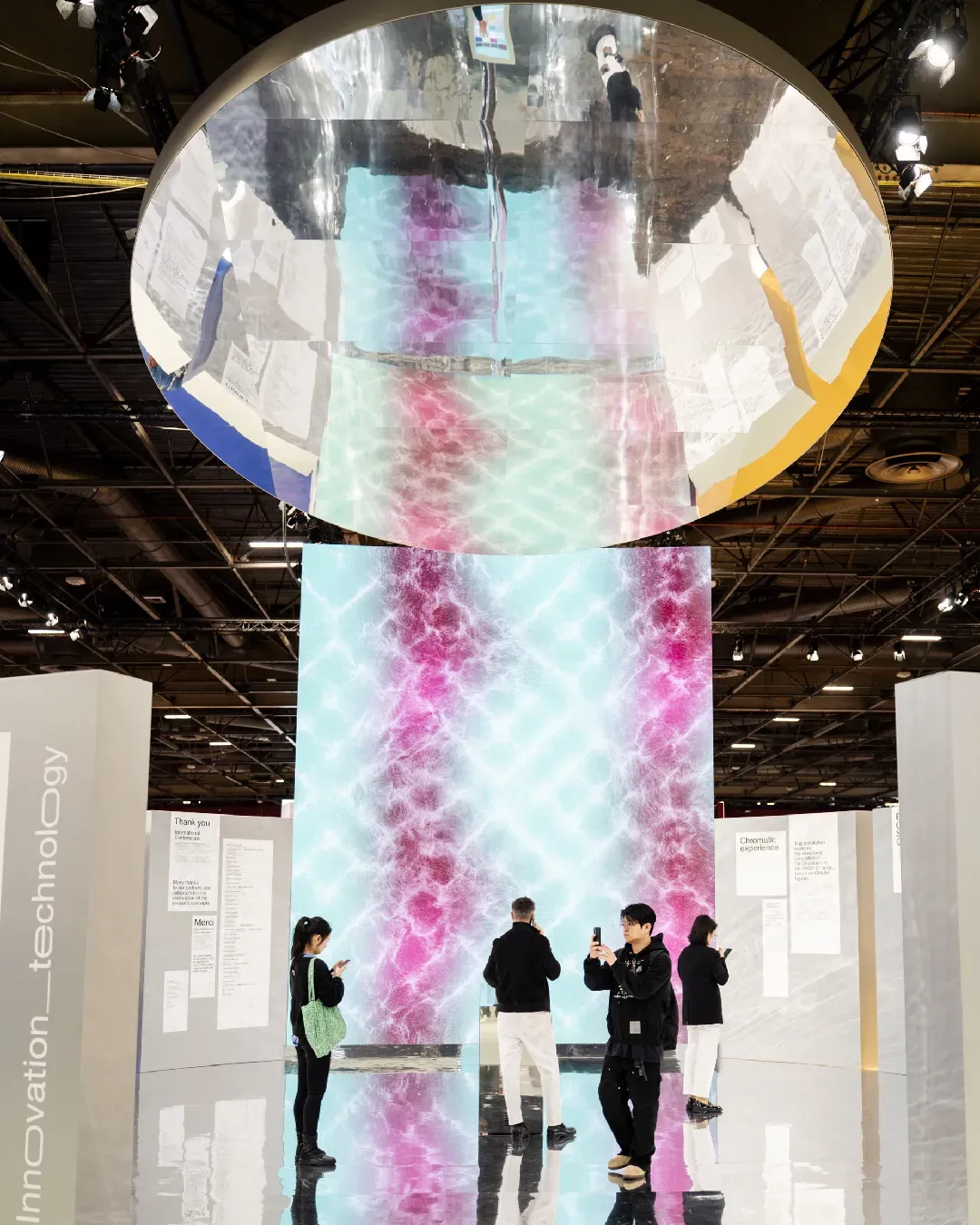Cos'è il “Made in Italy washing”? Quando un'etichetta non basta più
Parlare di Made in Italy oggi vuol dire avviare una conversazione sugli scandali e i problemi di produzione legati all’artigianato italiano. Perché di fronte alla marea di notizie legate al lusso in appalto di maison rinomate come Dior, Valentino, Armani e Loro Piana, e agli scioperi degli operai dei centri produttivi della Toscana e dell’Emilia, risulta difficile riferirsi ancora al Made in Italy come sinonimo di qualità ed eccellenza. Tutto ciò che è venuto a galla in questi mesi (così come il modo in cui la stampa lo ha comunicato al pubblico) ha trasformato radicalmente la percezione dei consumatori nei confronti dell’etichetta italiana, in un momento in cui il settore della moda è screziato su tutti i fronti geografici: i dazi di Trump hanno messo a rischio il futuro del lusso e del fast fashion in America, gli scontri e le guerre in Asia e Medio Oriente creato difficoltà nella supply chain globale, il tutto mentre la Cina, che fino a prima rappresentava il mercato principale dell’alta moda, adesso volta le spalle ai prodotti europei. All’interno della fashion industry si parla di Made-in-Italy-washing (da greenwashing, a indicare le false dichiarazioni dei marchi che vogliono il beneficio del marketing senza lo sforzo produttivo), ma basta parlare con chi lavora nella filiera produttiva italiana per capire che il washing c’è già stato, e adesso l’industria ne sta pagando le conseguenze. Ma di chi è la responsabilità? Chi deve darsi da fare per risanare la situazione? Lo abbiamo chiesto a Virginia Rollando, ingegnere industriale per lo sviluppo di strumenti di produzione sostenibili, e Francesca Strigi Loddo, founder di Ube Studio, agenzia di consulenza footwear che supervisiona l’intero processo produttivo per i brand clienti.
Partiamo dal significato che da sempre attribuiamo all’etichetta Made in Italy: qualità, artigianalità, rispetto e tradizione, aggettivi che fino a pochi mesi fa saltavano alla mente dei consumatori quando vedevano il bollino sulla suola di una scarpa o sull’etichetta di una borsa. «Spessissimo le persone pensano che il Made in Italy sia un simbolo di sostenibilità, in realtà questo non è sempre vero», spiega Rollando paragonando la percezione occidentale dell’etichetta al Made in Asia. In entrambi i continenti esistono ormai sia «fabbriche terribili che fabbriche molto sostenibili», ma se in Asia si lavora più sull’efficienza «dei materiali, dell’energia, sull’upcycling dei rifiuti e sul riciclo, perché tutto ha un valore», in Europa, e più in particolare nel lusso, dato che l’attenzione si sposta dalla quantità alla qualità ci sono sprechi e rischi maggiori. «In Italia ci sono ancora lavorazioni artigianali bellissime, però non ci sono dati, non viene controllata l'efficienza energetica o l’uso dell’acqua, in più la gestione dei rifiuti non è così trasparente e sostenibile come pensa il consumatore». E se nei paesi asiatici gli standard sono più bassi, continua Rollando, è perché le persone hanno standard di vita diversi; in verità, aggiunge, ci sono molti più controlli nella filiera asiatica che in Italia. «C’è talmente più paura che si presta molta più attenzione al fair trade. Il consumatore che compra il Made in Italy secondo me non sa neanche che in Italia non c’è neanche il salario minimo». Insomma, faremmo meglio a smettere di attribuire a un paese valori come la sostenibilità e la qualità: che si tratti di lusso, di artigianato o persino di fast fashion, il valore di un oggetto non dipende solo dal luogo in cui viene prodotto - tantomeno da quello che dice un bollino.
Ormai, afferma Rollando, «Made in Italy non vuol dire niente». Ci sono infinite informazioni più importanti di un bollino a rendere un capo etico e sostenibile. Il luogo di approvvigionamento dei materiali e di assemblaggio hanno relativamente un minimo impatto sul valore etico di un prodotto: «Che materiali sono stati usati? Sono stati rispettati i diritti delle persone che hanno contribuito alla filiera? L’articolo è di uno stile e di una qualità che lo rendono utilizzabile a lungo?» sono solo alcune delle domande più importanti che dovrebbero porsi aziende e terzisti, aggiunge Rollando, sottolineando che la dispersione della lavorazione, in Italia, ossia la suddivisione del lavoro tra gli ormai famigerati terzisti della moda, rende il Made in Italy una questione ancora più complicata come confermano le ultime notizie legate all’argomento.
Per Rollando, i danni all’immagine del Made in Italy riguardano in primis i brand e le grandi aziende, ossia chi ha il maggior profitto, le capacità finanziarie e il dovere di scegliere a quali produttori affidarsi - «ai brand conviene che la filiera sia spezzettata, ma se loro vogliono che rimanga così devono prendersi le responsabilità delle potenziali conseguenze». Per Francesca Strigi Loddo, che con Ube Studio ha proprio il compito di supervisionare l’intero ciclo produttivo, anche se riconosce che parte del danno è da attribuire alle aziende che scelgono di pagare meno e di “fidarsi” dei terzisti che agiscono senza trasparenza, buona parte della colpa va imputata alla stampa e ai social media, che con titoli sensazionalistici e testi poco esplicativi confondono il consumatore. «Per una scarpa, ci sono almeno dodici fabbriche che collaborano, e noi gestiamo tutto», racconta Strigi Loddo. «Il tema è scegliere i fornitori che hanno la tua stessa morale, persone che non schiacciano il prossimo per profitto, il che chiaramente costa un po’ di più». Essendo cresciuta in una famiglia di artigiani che creano scarpe da ben quattro generazioni, la fondatrice di Ube Studio ci racconta che la sua frustrazione più grande, in questo periodo così difficile per il settore intero, è l’impossibilità di informare i consumatori sulle differenze tra il Made in Italy di qualità e ciò che, invece, è solo etichetta.
Nella produzione di articoli di abbigliamento e di accessori, spiega la fondatrice, il livello di segretezza è eccezionale, tanto che diventa difficile anche solo condividere le proprie conoscenze online per rendere l’artigianato più accessibile. A causa dei contratti in esclusiva con i brand con cui lavora, Ube Studio non può rivelare nulla sulla propria produzione, un paradosso nella tanto celebrata trasparenza dell’artigianato italiano che danneggia più le aziende che cercano di proteggere il proprio marchio di fabbrica di quelle che potrebbero copiarle. Con i social media invasi da post che gridano allo scandalo dei terzisti, ma sprovvisti di contenuti informativi sulla manifattura italiana, regna la confusione. «C’è tantissima disinformazione, ed è il motivo per cui così tante persone dicono che il Made in Italy non esiste più», dice Strigi Loddo. «Questo secondo me è anche il motivo per cui i grossi brand non hanno mai funzionato su TikTok, dove puoi fare intrattenimento ma anche informazione». In un quadro in cui la moda italiana viene dipinta come un bene perduto, i brand hanno trovato riparo nell’estetica, su cui invece l’educazione non manca - basti pensare all’impatto che la nostalgia ha avuto nelle ultime Fashion Week, dal ritorno di it-bag passate al più generale dominio stilistico che esercitano intere decadi. Se Made in Italy fino a prima era sinonimo di qualità, oggi riusciamo a definirlo solo a livello emotivo, non tecnico.
Tornando al tema chiave, il Made in Italy washing non è da considerarsi una pratica scorretta utilizzata da tutti i produttori italiani, ma è arrivato il momento di andare oltre l’etichetta. Del resto, alcuni dei più grandi nomi della moda italiana non sono più solo italiani: Loro Piana è stata acquisita da LVMH nel 2013, Bottega Veneta da Kering nel 2001, Valentino da Mayhoola nel 2012 e così via. Diventa lecito, dunque, considerare il cambiamento di proprietà dei brand italiani come un momento catalizzante e trasformativo per il Made in Italy, non più in mano ai dirigenti, che in quanto italiani o discendenti dell’azienda di famiglia si sentivano in dovere di proteggerlo, ma affidato a chi oltreconfine lo utilizza solo per profitto - è difficile difendere la reputazione di un’etichetta, quando i poteri forti la deturpano a loro piacimento. «Perché Camera Moda non viene a parlare con noi, invece che con i grandi brand?» è una domanda che si chiedono artigiani, giovani impresari e operai che, come Strigi Loddo e tanti altri, devono assistere a progetti di supporto e investimenti indirizzati ad aziende già affermate, mentre il loro lavoro (quello artigianale, di cui sopra) finisce nel dimenticatoio. Perché scandali a parte, al Made in Italy adesso farebbe bene un po’ di compassione, sia da parte dei colpevoli che l’hanno danneggiata, sia dalla stampa che ne condivide la rovina con titoli fuori misura.