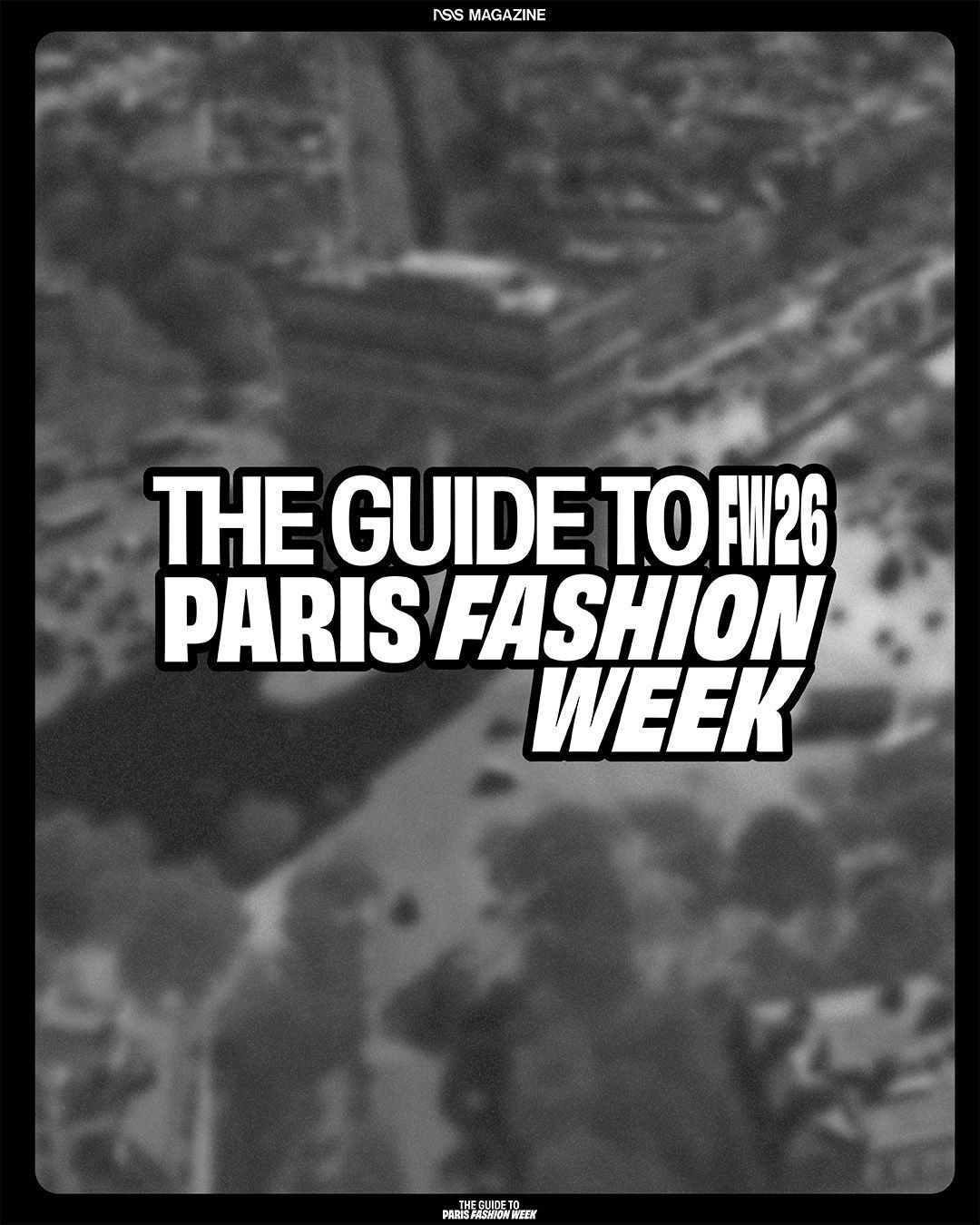Milano fa abbastanza per i suoi creativi emergenti? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro durante i giorni della fashion week
Per chi è fatta la fashion week? Ora che le sfilate diventano, stagione dopo stagione, dedicate ai talent e ai media team, in cui nei backstage si affollano più content creator che giornalisti e chi recensisce gli show spesso li guarda da uno schermo, il senso dell’intera esperienza inizia a venire un po’ meno. Se in passato la fashion week poteva essere letta come il momento-cardine in cui estetica, psicologia di mercato ed evoluzione semiotica convergevano sotto la forma di uno show, oggi il panorama delle sfilate si è appiattito tanto quanto il calendario si è ristretto. Discorso diverso va fatto per le presentazioni, dove designer indipendenti che ancora non lavorano in base ai diktat di team vendite, investitori e consigli d’amministrazione rimangono la carne viva di un sistema che sta soffocando e in cui mancano sempre di più idee e identità. In questa Milan Fashion Week Men’s il cui calendario è stato scarno come non mai, i (pochi) grandi brand avranno pure messo a lavoro i propri muscoli – ma i brand emergenti e indipendenti sono stati le ossa, la dimostrazione che a Milano la moda non è soltanto altro merch logato da far esplodere su TikTok o altri abiti concettuali che non vedranno mai la luce delle vetrine di Montenapoleone. Ma proprio qui sta il primo scoglio: quando oggi si apre un brand, come ci dice Matteo Lamandini di MTL Studio, «bisogna unire l’aspetto imprenditoriale e commerciale perché solo con la poesia si fa fatica, quindi si cerca di riuscire a coniare entrambe le cose insieme senza perdere l’aspetto poetico». Equilibrare tutto può essere meno semplice del previsto perché, come ci ha detto Antonio D’Andrea di MERIISI, «ti ritrovi a essere tutto quello che in un brand medio è gestito da almeno dieci figure diverse: produzione, comunicazione, direzione creativa, distribuzione, sviluppo, logistica, ricerca materiali… tutto. È estenuante, inutile negarlo, ma anche incredibilmente formativo».
Ma un po’ tutti i nostri intervistati hanno dovuto fare pace con la realtà delle cose. «La creatività è il nostro valore, ma l’imprenditorialità è ciò che ci permette di realizzarla concretamente», ci dice Sabrina Mandelli, creative director di SSHEENA. Altri, magari più creativi, devono ricoprire i due ruoli insieme per forza e spesso con un certo profitto, almeno personale: Leonardo Valentini, che dice di sentirsi più creativo, tende «ad avere la supervisione imprenditoriale su tutto o almeno ci provo» affidandosi il supporto del proprio team in cui ripone «molta fiducia»; per Alessandro Spaggiari di Via Piave 33 non c’è enorme contraddizione tra le due cose perchè «la creatività è sicuramente centrale ma deve trovare appoggio anche in un approccio più imprenditoriale per permettere a quest’ultima di durare nel tempo». Altri come Filippo Cascinelli vedono l’imprenditoria come «una forma di creatività applicata alla realtà». In generale, comunque, non sono queste sfide interne a preoccupare le nuove leve della moda milanese, che tutti in un modo o nell’altro riconoscono come una necessità, ma la stessa possibilità di emergere che spesso, oltre le vetrine fornite dalla Camera della Moda Nazionale Italiana o attraverso il supporto di Fondazione Sozzani e della insostituibile Sara Maino, non si propaga al resto del sistema. «Milano è ancora una piazza molto gerarchica, dove spesso lo status pesa più del contenuto. I nuovi nomi ci sono, ma faticano a trovare uno spazio reale, strutturato, che li valorizzi a pieno» ci dice Antonio D’Andrea, che continua: «Manca la volontà di investire nei processi, non solo nei risultati. Milano tende ancora a celebrare ciò che è già riconosciuto, consolidato, “presentabile”. Se non rientri in certe dinamiche, se non hai ancora il timbro giusto, rischi di rimanere invisibile». Anche per Lamandini, che ha molto lodato il lavoro di Fondazione Sozzani, «servirebbe più fiducia da parte dei buyers, molto restii a comprare brand emergenti. Oltre al sostegno dato da Camera Moda, credo che manchi la parte successiva». Per Leonardo Valentini, convinto che «ci sia un po’ di ipocrisia in generale», le cose sono simili: «Una volta riconosciuto il valore bisognerebbe renderlo più visibile al mondo».
La verità forse è che, come struttura, la fashion week dovrebbe, come ci ha detto Alessandro Spaggiari, «dare più supporto mirato per costruire progetti solidi e non solo momentaneamente interessanti per portare reale interesse da parte del pubblico internazionale su Milano non solo per i grandi nomi ma anche per progetti più nuovi». In effetti va detto che quello delle fashion week è un meccanismo forse ormai antiquato per brand emergenti che possono sfruttare i mille altri palcoscenici dei social media ma, per farsi riconoscere, è l’unico strumento possibile. In assenza dei budget che ha, per esempio, Jacquemus per organizzare i suoi celebri show scenografici e di enormi community già nate nel mondo digitale (assai più rare quelle organiche) i designer continuano ad avere bisogno della fashion week - ma servirebbe fare di più? Secondo Filippo Cascinelli «ciò di cui si sente il forte bisogno sono i mezzi concreti per trasformare le proprie idee in progetti sostenibili», ci dice, «accesso ai finanziamenti, fiducia da parte dei retailer, spazi di produzione e visibilità. La mia idea è che, nel tempo, si possa costruire un sistema più strutturato a supporto delle nuove generazioni». E mentre Antonio D’Andrea cita le medesime preoccupazioni riguardanti «spazi curati ad hoc, supporto reale, non solo di visibilità ma anche tecnico, produttivo, narrativo» anche Sabrina Mandelli di SSHEENA ammette l’esistenza del problema: «Lo spazio c'è, ma non è ancora sufficiente e, soprattutto, non è di pari livello. «Farei in modo che i designer giovani abbiano la stessa possibilità di aumentare la loro visibilità», prosegue Mandelli, «magari sfilando e facendo in modo che nel calendario i brand già affermati siano distribuiti in modo equo su tutta la durata della fashion week, come fanno a Parigi». E qui veniamo al dunque: c’è uno spettro che si aggira per Milano ed è lo spettro di Parigi.
Diversi insider incontrati a Milano questi giorni hanno parlato della differenza sempre più forte che si stente tra Milano e Parigi, dove si avverte la presenza di un ecosistema, un humus culturale e professionale che nella più commerciale Milano forse manca. Basti pensare a Magliano, ad esempio, forse il più celebrato dei “nuovi” nomi italiani, che a carriera avviata viene ancora definito emergente mentre designer che hanno più o meno la medesima età come Ludovic de Saint-Sernin o Duran Lantik, a Parigi, ottengono anche direzioni creative assai importanti. Forse più poetico, per Leonardo Valentini «manca la famosa Sala Bianca di Palazzo Pitti, che in quel caso non era a Milano», concede scherzosamente «ma che comunque creava una connessione in cui diversi emergenti con caratteristiche e target ed estetiche diverse si connettono per appunto emergere. Ai tempi c’era Giorgini, e infatti brand che facevano parte di quel sistema come Valentino sono nel firmamento. Ci vorrebbe un altro Giorgini a trainarci». Antonio D’Andrea di MERIISI invece parla negli stessi termini di Londra, dove ha trovato «una libertà di espressione reale, una cultura progettuale che ti invita a osare, a cercare, a rompere». Un’esperienza che ha insegnato al designer «che prima ancora di uno showroom, di una sfilata o di un investitore, un giovane designer ha bisogno di spazio mentale e culturale per potersi costruire» il che implica che a Milano sia necessario «un cambio di prospettiva: più apertura, più fiducia, più pazienza. Il nuovo ha bisogno di essere accolto anche quando è scomodo, quando non è ancora perfetto». Per Mandelli di SSHEENA, «Milano deve avere il coraggio, la pazienza ed il tempo necessario per credere nelle persone giuste. Il grande equivoco del giorno d’oggi è che spesso si fanno paragoni con brand che hanno una storia di 50, 100 o addirittura 140 anni».
Il problema è forse culturale: l’elemento novità presentato dall’avere una schiera di “emergenti” non si traduce mai in quella chiara equivalenza o equiparazione tra brand nuovi e storici che si vede alla Paris Fashion Week e che apre la strada a narrazioni più complesse. Spesso quella degli emergenti è una categoria dove i designer vengono relegati senza che all'annuncio del loro esordio ci sia un vero seguito - emergenti in perenne emergenza. Ma questi designer non sono un riempitivo: sono la parte più viva di un sistema dove sono le istituzioni ad anchilosarsi e invecchiare. Servirebbe piuttosto che anche i grandi protagonisti della moda di Milano riescano a fare rete, riconoscere il talento, e non tenere gli emergenti nel limbo per sempre. Per Alessandro Spaggiari di Via Piave 33, ad esempio, «c’è bisogno di vedere nei giovani non solo una forza creativa ma di saper individuare, da parte delle istituzioni, la visione e le possibilità di sviluppo di un progetto all’interno del mercato. Come dicevamo prima si tratta sempre di creare un giusto equilibrio con lo scopo di far crescere i progetti in modo sostenibile». Anche per Antonio D’Andrea servirebbe «un cambio di mentalità anche tra i creativi. Troppo spesso si ha paura di condividere, come se un’idea potesse essere rubata. Se fossimo tutti più fedeli alla nostra voce, ci sarebbe meno competizione sterile e più contaminazione sana». Servirebbe anche, aggiungiamo noi, che il riconoscimento del valore di un progetto non passi dalle lodi di entità esterne e che anche gli insider e i creativi “established” supportino in prima persona il lavoro della nuova generazione. In generale, se vogliamo che la moda a Milano torni a essere sinonimo di vera e vitale cultura oltre che di commercio, c'è bisogno che la prima community sia quella tra i brand e i creativi stessi, e fra i grandi della moda istituzionale e i nuovi nomi indipendenti - la cultura, dopo tutto, non si fa mai da soli.