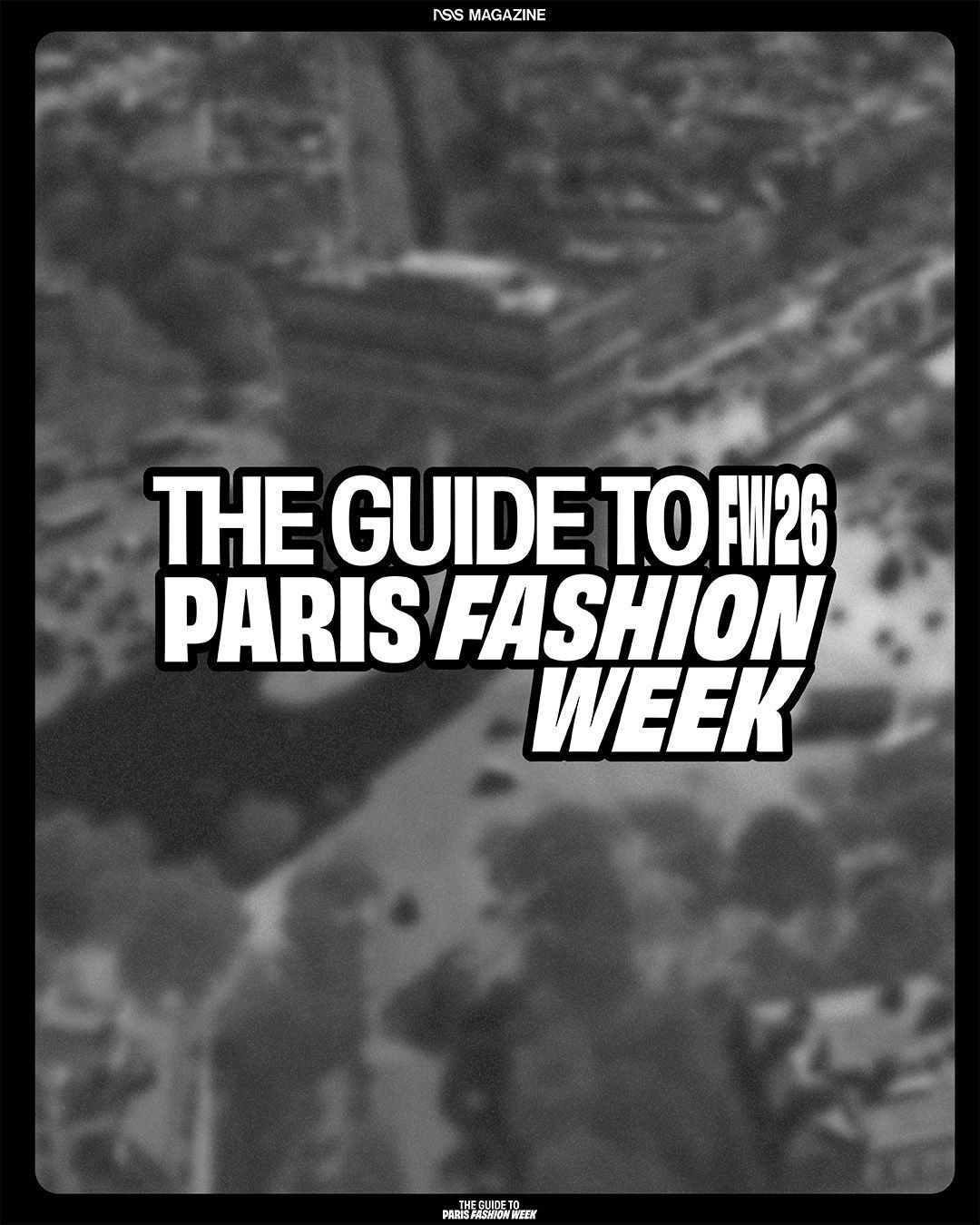L'estetica Indie Sleaze era davvero bella come la ricordiamo? Il revival di un epoca non dev’essere per forza il revival dei suoi aspetti più cringe
Uno degli aspetti più noti e più ignorati della condizione umana è la capacità che le persone hanno di guardare al passato con occhi molto più clementi di quelli con cui si guarda il presente. La memoria, come una nevicata, copre ogni scena di poesia nascondendo il prosaico, lo sgradevole e persino il brutto. È ciò a cui assistiamo oggi con il ritorno del mondo Indie Sleaze che, dopo un iniziale revival diversi anni fa, oggi sembra essere diventato un’installazione permanente nella nostra iper-frammentata cultura pop contemporanea.
C’è solo un problema. Per chi, come chi sta scrivendo queste parole, ricorda quell’epoca per averla vissuta, l’Indie Sleaze non è l’estetica cool e creata ad arte che si vede oggi su TikTok, anzi. A dirla tutta, si potrebbe quasi arguire che l’odierno trend Indie Sleaze non sia altro che una forma di revisionismo culturale in cui si accorpano sotto un singolo ombrello fenomeni e mode molto diverse tra loro, ma coesistenti in quegli anni. Si tende, cioè, ad accorpare il mondo dell’indie rock (quello di Pete Doherty e degli Strokes) con quello degli hipster (pensiamo ai Lumineers e la “clap stomp music”) mescolandoci anche la cultura di Tumblr e l’estetica tamarra Y2K di Paris Hilton e Jersey Shore detta Nu Bling.
Si tratta però di un’epoca della cultura ben delimitata (come paletti temporali generici potremmo farla iniziare con gli attacchi dell’11 settembre e finire con la fondazione di Off-White nel 2013) anche se difficilmente definibile e abbastanza multiforme. Ha dunque senso, un po’ come si fa con gli anni ’80, unificarla retrospettivamente in una singola prospettiva nostalgica. Occorre però ricordarne, per giustizia, anche gli aspetti, non diciamo brutti, ma quanto meno cringe. Qual era il peggio dell’era Indie Sleaze?
Eravamo davvero vestiti così bene?
La silhouette dell’epoca trovò la sua massima espressione nelle collezioni di Hedi Slimane da Dior e di Christophe Decarnin per Balmain. Era l’esatto opposto di quella dominante oggi: invece che stretta sopra e larga in fondo, preferiva le gambe attillate e i top oversize. In molti casi, il top tendeva a scendere come una tunica sulle gambe fasciate dai jeans o anche solo dai collant, che all'epoca si portavano sotto gli shorts di jeans. Nella moda lo stile non mancava di certo, ma nel mondo dei comuni mortali il trend creò non poche storture: skinny jeans indossati a vita bassa, collari alzati e recanti grafiche al loro interno, leggings di ogni colore, lunghe canotte con slogan tristemente ironici.
Il pezzo di vestiario più famigerato dell’epoca sono sicuramente i Disco Pants di American Apparel, ovvero leggins aderenti di spandex luccicante che negli USA divennero tanto famigerati da meritarsi una pagina di Wikipedia. Forse però il marchio distintivo più odiato globalmente erano i cappelli a tesa larga resi popolari da icone bohemien come Pete Doherty e Johnny Depp che poi invasero rapidamente i guardaroba dei giovani Millennial con bombette spiritose, porkpie hat e orribili fedora come quelli indossati da Justin Timberlake e Ne-Yo all’epoca.
omg are we going back to sexy business casual for the club?! lol pic.twitter.com/0WrsKIdzN2
— Taesty (@BrownSugarTae) November 18, 2025
Altra terribile piaga estetica era il cosiddetto “business casual” che rese per anni il miglior outfit per andare a ballare un blazer con un top pieno di rouches, un mega-cinturone dal colore stridente, skinny jeans e tacchi. La mania del business casual, che poi verso la fine del periodo virò verso territori western/ottocenteschi, portò anche alla diffusione delle francesine, o brogues, ovvero le scarpe di pelle stringate con la mascherina sul davanti. Per completare il tutto, poi, non potevano mancare dei giganteschi occhiali in ovvia contrapposizione ai tagli di capelli con le frange di lato à-la-Justin Bieber che, spesso, erano pure indossati senza lenti.
La tendenza a decorare tutto sempre, poi, portò al rigoglio della bigiotteria (ai tempi negozi come Accessorize erano i luoghi caldi della cultura) con monili a tema hipster come il celebre pendente a forma di gufo e soprattutto portò ai polsi di uomini e donne quantità smodate di braccialetti di ogni tipo che diventavano una specie di diario della vita di chi li indossava: perline di plastica, bande di gomma, braccialetti piastrati in acciaio, pass di festival e di serate in discoteca.
Il richiamo dell’esotico
this comes from the early 2000s. It was used for a specific kind of tribal tattoo popular at the time. The term was derogatory as tattoos in western countries had not yet become widely accepted in the eyes of the public pic.twitter.com/1PrCizwf7m
— Max Aveniedas (@KnightmareAlpha) August 31, 2022
Nei primissimi anni 2000 una delle cose più cool che c’era erano i famosi “tribali” originariamente inventati dal tatuatore Leo Zulueta a fine anni ’80 nel leggendario studio di Los Angeles Spiral Tattoo. Dopo una prima diffusione negli anni ’90, piombarono sulla cultura mainstream come i Labubu sono piombati su di noi nell’anno appena trascorso. Dalle maglie di Ed Hardy ai tatuaggi di David Beckham, dalle camicie pseudo-hawaiiane decorate da draghi stilizzati fino ai tatuaggi con lo sticker che si trovavano nei pacchi di patatine, quei motivi erano ovunque. Oggi lo chiameremmo un’operazione di appropriazione culturale, essendo quei tatuaggi ripresi a piene mani da quelli della cultura samoana e in generale dalle popolazioni del Sud Pacifico.
@90sbaby2000s_teen Did you own one? I remember wearing a Magenta one with a SpongeBob tee in like 2007… #keffiyehscarf #keffiyeh #2007 #2007trend #2000strends #2000sfashion #petewentz #falloutboy #scenefashion #hipsterfashion #2000steen #2000steenager #heytheredelilah #emoscene #emoscenegirl original sound - Jacoby
C’era poi la kefiah che, dopo il panico anti-islamico diffuso con l’11 settembre e l’inizio della Guerra in Iraq, divenne in Occidente un generico simbolo di chi voleva ribellarsi al sistema, simile alla t-shirt di Che Guevara, e che era venduta tanto da brand di moda avant-garde come Raf Simons che ne incluse una nella celebre FW01 e Balenciaga, che invece la creò per la FW07, quanto da negozi come Topshop e Urban Outfitters o anche i vari Zara e H&M che all’epoca iniziavano a diffondersi.
@sarahhiraki It's more problematic orientalist fashion from the likes of Seventeen Magazine and Delia's! Did you own any of these? It's time to look back, cringe, and do better in this decade. #stopasianhate #orientalism #y2kfashion #90sfashion #japonisme #chinoserie #fashionhistory #learnontiktok Lofi nostalgic old music box(833007) - NARU
Né si potrebbe evitare di citare la fascinazione collettiva e superficiale che si ebbe per la cultura asiatica, giapponese e cinese in particolare, che andò dalle scritte sui vestiti all’intero franchise di Pucca (che veniva però dalla Corea del Sud) fino alla moda del qipao ossia il vestitino cinese con lo scollo asimmetrico che spesso era completato con due bacchette tra i capelli. Simbolo di questa sorta di neo-orientalismo è l’art direction dei video di Gwen Stefani con le Harajuku Girls o il famoso shooting di Karlie Kloss vestita da geisha su Vogue.
Una strana teoria dei colori
Infine, tra proporzioni ristrette e allungate, tacchi col plateau, felpe zip abbinate a camicie e jeans strappati, a regnare era una teoria dei colori del tutto disarmonica, per non dire volutamente caotica. Si puntava molto su un mix "mismatched" che dava l'impressione di aver preso pezzi a caso da due o tre guardaroba diversi. Sicuramente la base dominante era il nero, quasi onnipresente su skinny jeans, giacche di pelle, hoodie e blazer. Secondo al nero era il bianco ottico, abbagliante e sintetico, molto usato per i famosi shutter shades ma anche per la combinazione di camicia nera e cravatta bianca che tante vittime ha mietuto negli anni.
Su queste basi si ammassavano molti accenni metallici e luminosi, tra borchie e tessuti lamè; abiti color verde acido, rosa shocking, arancio o blu elettrico specialmente su t-shirt, sciarpe e calze. Ci fu un anno in cui il viola e il melanzana andarono tantissimo. Amatissimo era un tocco di rosso brillante per scarpe, borse, cinte e nei casi peggiori anche pantaloni, mischiati insieme a grafiche molto vistose e invasive oltre che stampe animalier. Anche i pastelli e i neutri erano vagamente “sporchi”. Tutto uno stile che voleva evocare, non tanto i rave veri e propri, quanto le feste così simili a quella del film Project X che arrivò, in effetti, proprio in coda