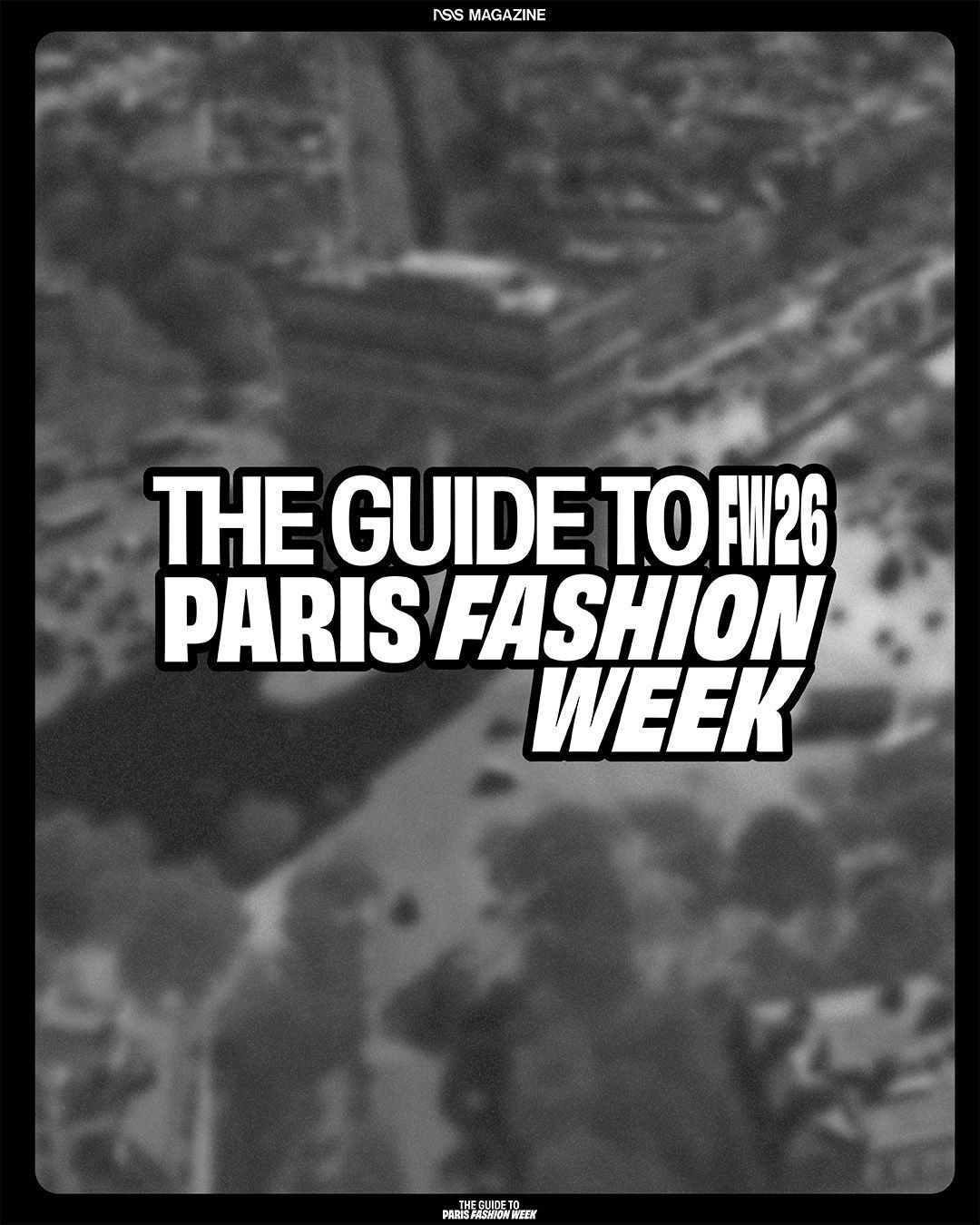L’archivio ha ucciso il vintage? Come il tardo capitalismo ha invaso l’anti-capitalismo
Chi scrive questo articolo compra vintage a Milano da dieci anni. C’era un’epoca, quando la Fiera di Sinigaglia si teneva nell'Ex Scalo Ferroviario di Porta Genova e non sul Naviglio Grande, in cui tra le bancarelle si trovavano per una manciata di spiccioli vecchi Levi’s, maglioni di cachemire, giacche di pelle oltre che un gran numero di articoli firmati che trovare in mezzo a pile di roba era la missione di ogni sabato mattina. Una memorabile mattina un amico trovò un cappotto anni ’60 di Gucci in condizioni quasi perfette, un’altra dalla bancarella solita emersero cappotti e giacche Corneliani e camicie di Fendi, Valentino e Dior. Tra i trofei più assurdi di quella stagione, tutti trovati a meno di 25€, si contano un gilet tattico in nylon di Gianfranco Ferrè, un altro in pelle di Versace, pantaloni di Loro Piana e Cerruti, maglioni di Stone Island, blazer di Zegna, completi storici di Armani e Canali – e questi sono solo i capi firmati, centinaia di altri non lo erano ma includevano maglioni a trecce di pura lana merino, camicie di seta, completi da tennis anni ’80 e un numero di pantaloni sartoriali che è meglio non precisare per non destare preoccupazioni in chi legge. Anche nei negozi vintage di via Mora a Milano si facevano grandi affari: una t-shirt della collezione SS04 di Comme des Garçons Homme Plus a 17€ e camicie di Balenciaga dell’era Ghesquiere a 24€ e un montone rovesciato di Valentino a 50€ sono ancora tra i migliori ritrovamenti, ma si può dire anche che furono gli ultimi grandi affari che si fecero in città. Oggi, ai tempi delle piattaforme secondhand di lusso, in un’epoca in cui persino Farfetch vende per centinaia di euro delle polo di Pierre Cardin che una bancarella avrebbe venduto per circa 5€, non solo le bancarelle vintage vanno riempiendosi di pezzi di H&M e Stradivarius, ma quell’intero mondo è ormai al suo tramonto.
Diciamolo chiaramente: quel mondo del vintage era bello perché consentiva a uno studente universitario per cui anche certi maglioni in lana e poliestere di Zara a 40€ erano troppo costosi di accedere, o almeno illudersi di accedere, prima di tutto a capi di qualità superiore (anche se certamente datati) e in secondo luogo a capi firmati altrimenti inarrivabili. Era un’oasi di anti-capitalismo in un deserto iper-capitalistico fatto di brand fast fashion di dubbia qualità, brand di streetwear già costosi e altri di lusso invece inarrivabili. Un mondo a volte sporco e caotico ma in cui la conoscenza, la fantasia e l’iniziativa personale giocavano un ruolo importante nella ricerca di “pezzi” incredibili. Poco si faceva online: Grailed era una realtà più viva al di là delle Alpi e dell’Oceano, Depop era un mercatone non troppo diverso da quello che si teneva il sabato che però già all’epoca era perfetto per recuperare vecchie hoodie di Stussy e Levi’s a buon mercato. Poi arrivò l’archivio: mentre i negozi vintage di Milano si riempivano di brand come Les Hommes, Les Benjamins e HerosHeroine e i prezzi della “vera” moda secondhand lievitavano, siti come Silver League e Middleman Store diffondevano la cultura dei brand avant-garde e della moda anni ’90 di Jean Paul Gaultier. I prezzi, in dollari, erano considerevolmente alti ma c’era un motivo, una ricerca alle spalle: il vintage si era espanso in una nuova, ancora più elitaria categoria culturale. Poco a poco quella cultura si diffuse tra i giovani conoscenti della moda, Vestiaire Collective trovò una diffusione enorme e il boom della moda secondhand iniziò più o meno come lo conosciamo. Poco più tardi arrivò anche Vinted, che fece diventare il secondhand nazional-popolare e che rimane a oggi forse l’ultimo erede di un mondo del vintage autenticamente democratico. Eppure, quando si vide a Milano la pubblicità di Vinted sulle fiancate dei tram, quel mondo del vintage era già morto e sepolto, il suo segreto era stato rivelato e quella democraticità assoluta era perduta.
La parabola di questo cambiamento potrebbe essere descritta come il progressivo incontro della cultura del vintage con la cultura del resell: il primo nasceva sulle bancarelle e riguardava i brand di lusso tradizionale, il secondo nasceva online e riguardava lo streetwear. Le due categorie si mescolarono facendo nascere i grandi marketplace online e, prima che chiunque se ne accorgesse, i brand stessi iniziavano a vendere i propri capi vintage a prezzi leggermente inferiori dei capi delle boutique e Farfetch avviava il suo programma pre-owned che è sicuramente nobile nelle intenzioni ma che ha di base ricostruito la barriera dei prezzi che il mondo del vintage abbatteva. Persino l'amato East Market di Milano o il Mercatone dell'Antiquariato mensile divennero famigerati per alcuni prezzi decisamente astronomici: durante l'ultima edizione del Mercatone dell'Antiquariato a chi scrive venne proposto un prezzo non trattabile di 100€ per un paio di occhiali di Gianfranco Ferrè vecchi di trenta o quarant'anni. Con Vinted e Vestiaire Collective, poi, molti utenti iniziarono a capitalizzare su quelle che prima erano vendite per svuotarsi l’armadio e dunque anche su quelle piattaforme arrivarono i cappotti a 5000€ e le scarpe a 800€. La situazione è andata così tanto fuori controllo, in effetti, che in certi casi vengono messi in vendita capi che costano tanto quanto in boutique – i grandi affari sono sempre meno e persino i capi di moda subiscono un overpricing sempre più eccessivo. Il gioco funzionava quando il vintage era una grande giungla non regolata: ciò che succedeva succedeva. Ora che quella giungla è stata colonizzata da grandi aziende e venditori privati, però, le sue logiche sono diventate le stesse del mercato firsthand – più controllate ma di nuovo tragicamente esclusive.
I've found out where all the Milanese hipsters go on Sunday. #EastMarketMilano pic.twitter.com/FJ2kUpttKR
— John Lubbock (@jwsal) February 23, 2020
Nel frattempo anche qualcos’altro è accaduto al vintage. Da un lato i brand di fast fashion hanno iniziato a “inquinare” il flusso di capi in lana super 100s, chiodi di pelle e camicie sartoriali di cotone, dall’altro l’accresciuta cultura del resell ha portato molti a voler vendere privatamente i capi prodotti dai brand più rinomati con il doppio risultato di annacquare la selezione del vintage e di impedire quel meccanismo per cui capitava, poniamo, che si riuscisse a trovare un raro capo firmato in mezzo alla proverbiale “pila di roba”. Nel frattempo una nuova generazione di venditori di vintage Instagram-native (di cui parla Fashionista) ha iniziato a popolare il mercato con selezioni di capi dai prezzi non luxury ma nemmeno lontanamente accessibili come quelli degli originali thrift stores. Tutti questi elementi hanno portato, nel 2022, a un mondo vintage molto diverso da quello di dieci anni fa: più preparato, sicuro e "filtrato", ma per certi versi meno entusiasmante e avventuroso. Un articolo del The New York Times di nome The Golden Age of Thrifting is Over nota come la marea di prodotti fast fashion non ha solo intasato e creato problemi ai negozi di vintage ma anche ai grandi marketplace come ThredUp: «Rispetto al 2020, c'è stato un aumento del 186% nel numero di articoli elencati da Shein e un aumento del 75% di pezzi provenienti da PrettyLittleThing». Il senso dell’articolo si condensa in questa frase: «Questo è allarmante per le generazioni di donne che per decenni hanno fatto del thrifting un modo per riempire i loro armadi a prezzi accessibili con capi realizzati con materiali di alta qualità». Persino su Vinted bisogna filtrare attentamente i risultati della propria ricerca per evitare di trovarsi davanti capi usati di Zara o Bershka. Chi vorrebbe mai del fast fashion usato? Il vintage non è solo convenienza economica, dunque, ma democraticità e circolarità – uno dei rari meccanismi virtuosi che esiste all’ombra dell’industria della moda “vera”. Eppure esiste ancora una speranza.
Applicando una semplice logica “storica” possiamo ragionevolmente presumere che, proprio come le tonnellate di prodotti vintage del passato hanno alimentato e alimentano ancora il mercato vintage di oggi, alla stessa maniera l’enorme sovrapproduzione di brand high street e streetwear degli anni ’10 finirà a un certo punto per alimentarlo in futuro. Dopo tutto già nel 2015 il couturier Olivier Theyskens lamentava, sulle pagine di Dezeen, «il surplus di giovani designer che avviavano il proprio brand» e la saturazione del mercato della moda – problema che si sarebbe decuplicato con il fenomeno degli “startup brand” che vide centinaia di giovani creativi lanciare proprie linee di abbigliamento facendo stampare hoodie o t-shirt rincorrendo l’esempio tracciato da Virgil Abloh o degli altri brand sparsi per Europa, Asia e America diventati negli anni dei microfenomeni. Un rapido giro nella sezione delle Fashion News di Hypebeast conferma l’esistenza di brand mai sentiti prima che sembrano essere apparsi nel giro di una notte come funghi dopo un temporale, alla stessa maniera scorrendo la lista di tutti i brand commercializzati da Farfetch o SSENSE si scopre che i brand delle fashion week vere e proprie sono una netta minoranza rispetto ai tanti illustri sconosciuti che popolano la categoria. Allo stesso modo, nel mercato italiano, i brand locali che producono abbigliamento di fascia alta registrando incassi ma senza mai vedere la luce dei riflettori («onesti produttori» li definiva Andrea Batilla in un articolo scritto l’anno scorso per nss magazine) esistono nell’ordine delle migliaia. E, proprio come oggi la valanga di giacche e pantaloni dei nostri nonni dice qualcosa su un’epoca poco colorata e molto formale, forse tra molti anni anche i nostri nipoti troveranno le reliquie della nostra epoca sulle bancarelle e nei negozi vintage della loro. Ammesso che il mondo come lo conosciamo esista ancora.