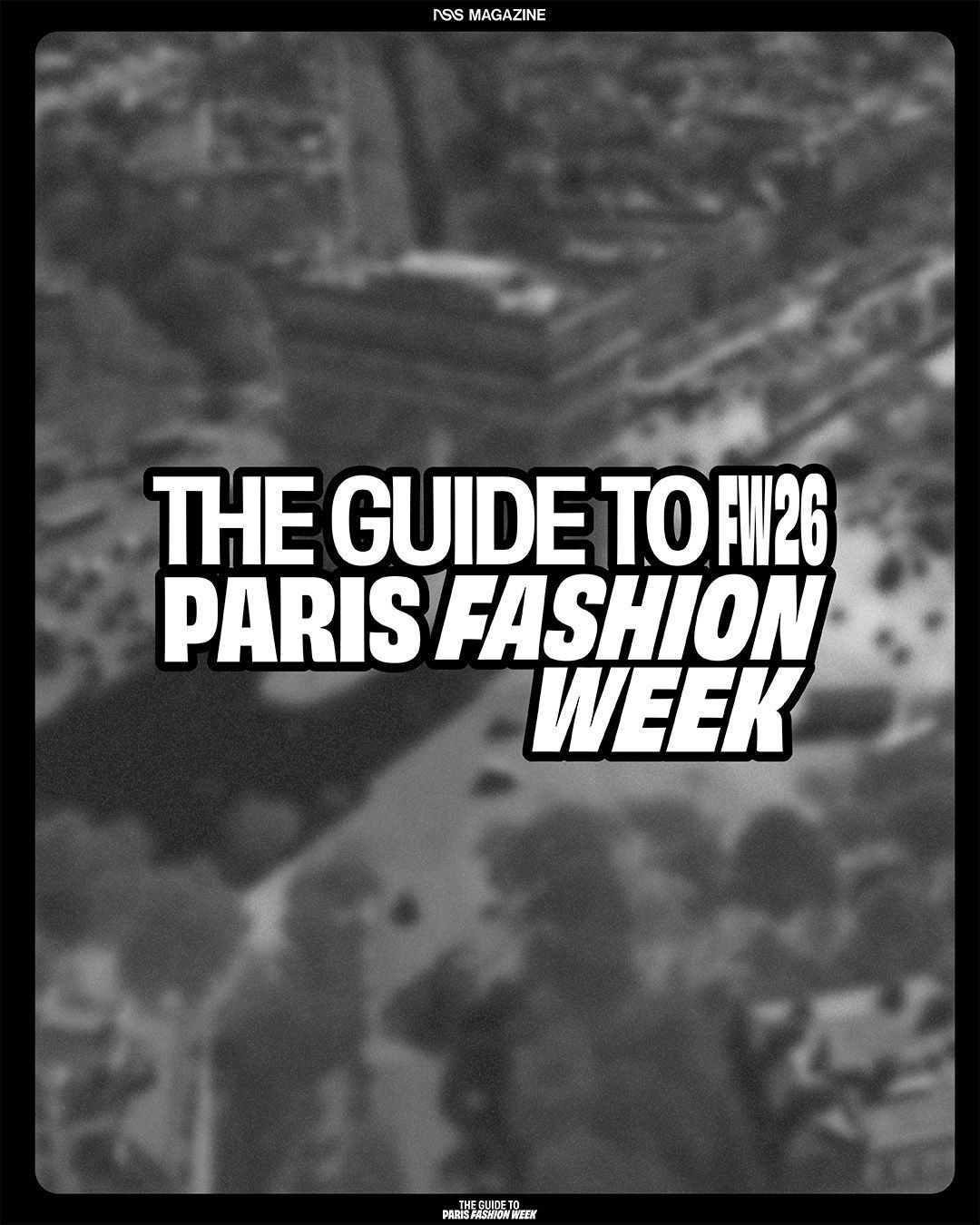Chi ha ancora bisogno delle sfilate? Phoebe Philo, Hedi Slimane, le Olsen – quando il lusso non si scomoda
Quando il lockdown costrinse la moda a ripiegare sul formato digitale per presentare le proprie collezioni, nulla pareva bello come una sfilata dal vivo. Oggi però la situazione è invertita: perdendo la propria presa sulla realtà con show performativi i cui look spesso non vengono nemmeno prodotti, le sfilate risultano oggi tanto eccitanti quanto poco necessarie. Almeno per quei designer il cui stile è così noto al pubblico che sono capaci di rappresentare col loro solo nome un’intera estetica. Rispondendo alla domanda su un suo eventuale futuro show, Phoebe Philo ha detto al New York Times: «Nel mondo di oggi, dove c'è così tanta moda, e tanta moda sensazionale, cerco di ricordare che la maggior parte delle grandi case ha iniziato con un essere umano che aveva un'idea su ciò che voleva fare». Parole che sintetizzano un atteggiamento molto pratico e diretto della designer che «vede il suo lavoro come una collezione continua e non crede alle stagioni» e che è tornata all’industria da semi-indipendente e con un modello di business quasi da “azienda a conduzione familiare”. Un altro designer che ha abbandonato le passerelle da un po’ di tempo è Hedi Slimane, le cui collezioni sono presentate con video pubblicati a cadenze deliberate, e il cui ultimo show per Celine ha lanciato una linea di beauty che, senza grandi fanfare, ha creato hype in mezzo mondo. Altri due casi: Y/Project che rinuncia allo show salvo poi pubblicare uno dei lookbook più cool e carichi di celebrità mai visti di recente e le gemelle Olsen che la sfilata l’hanno fatta ma senza farla vedere quasi a nessuno, limitandosi a condividere un lookbook sui social. Tutti momenti che segnalano, come minimo, l’incipiente crisi del modello della sfilata – ma perché?
In origine la sfilata serviva a mostrare abiti e modelli di stagione alla stampa e ai buyer, tramite di essi la collezione veniva raccontata al pubblico e arrivava poi nei negozi. Quando negli anni '60 Balenciaga si rifiutò di mostrare le collezioni alla stampa per timore di plagi, senza ancora il supporto delle fotografie e dei social, l'intera stampa di moda si rivoltò, la cosa era inaudita. Oggi le cose sono diverse: la sfilata la possono vedere tutti e, funzionalmente parlando, ogni sfilata è un videoclip per il grande pubblico globale che in fin dei conti la guarda comunque su YouTube – l’esperienza dal vivo è riservata a relativamente pochi insider e soprattutto agli ospiti VIP in front row che, ad esempio nel caso di Dior, hanno ricevuto sui social più click e interazioni degli stessi look della collezione. Secondo i nostri calcoli, i post dedicati ai look dell'ultimo show, trentadue in totale, hanno registrato un'interazione complessiva di 1,1 milioni con una media di 35.000 interazioni per singolo post, mentre i post sui VIP sono stati 9 con un totale di 1,8 milioni di interazioni e una media di 204.000 interazioni per singolo post: i VIP hanno ottenuto un'interazione media 5,8 volte superiore rispetto a qualunque look. Inoltre, brand grandi e piccoli comunicano tutti allo stesso modo online o sui social media, con il budget delle campagne ormai destinato alla celebrity di turno che poserà su uno sfondo neutro. Sul piano dello shopping online, brand e posizionamenti diversi vengono resi tutti uguali dalla grande livella dell’e-commerce e l’unica grande differenza tra i brand di lusso e tutti gli altri è l’esperienza in negozio, che è anche perché così tanti brand stanno investendo in mega-boutique e in spazi commerciali sempre più grandiosi. Ma quando si parla di presentare il lavoro al pubblico e non di venderlo al dettaglio ci sono troppi brand, troppe collezioni e troppi show – e distinguerli comincia a diventare difficile. Quante volte è capitato, nella scorsa stagione, di vedere un certo cappotto o trench che sarebbe potuto appartenere a cinque o sei brand diversi?
@limelightnova WHAT A PIECE! IT MADE OUR DAY! Phoebe Philo’s highly anticipated debut collection Message us for more details. #phoebephilo #phoebephilostudio #phoebephilobag #fyp #phoebebag #trending Love on the Weekend - Aria Ohlsson
Anche a fronte di collezioni validissime viste quest’anno, la sequenza di show e sfilate, così come la fretta che domina i calendari sovraffollati, ha reso le fashion week una liturgia meccanica e ripetitiva, tra la rassegna e la marcia forzata. Quando le Olsen hanno deciso di non rendere pubblica la sfilata di The Row, però, se n’è parlato per giorni interi: al di là del trucco di marketing che alimenta il mistero e l’attesa, l’idea era quella di costringere i presenti a essere presenti, magari prendere anche appunti, senza guardare lo show dallo schermo del loro telefono per poi scappare all’appuntamento successivo. Eppure molti influencer non hanno gradito: il loro lavoro, infatti, non è di vedere lo show o di valutarlo, ma di creare social media content – senza quest’ultimo, la loro ragion d’essere viene meno. Ciò che le Olsen hanno fatto a Parigi è stato mettere in dubbio, non tanto lo status della sfilata, ma lo status di chi la va a guardare e di chi la può guardare: un semplice ma rivoluzionario cambio di prospettiva. E dato che ciò che i brand cercano dalle sfilate sono attenzione e EMV e il loro scopo non è più quello di presentare una collezione che poi i buyer guarderanno comunque in showroom. E il cambiamento nella destinazione d’uso delle sfilate stesse ha in parte eroso il loro significato: molti show, oggi, sembrano rituali comunque preferibili al silenzio stampa ma non si può certo dire che siano “eventi” dato che sono in primo luogo brevissime, in secondo luogo schiacciate in calendari ultra-affollati e in terzo luogo spesso disconnesse dall’effettivo prodotto finale. Per non parlare della frequenza con cui queste collezioni arrivano: una ogni tre mesi in alcuni casi, tutte di prodotti bene o male generici anche se ben fatti.
This statement is a reflection of the fact that fashion has no longer is, in the public’s eye, a niche craftsmanship and trade-based industry.
— Kanika Talwar (@Kanika_Talwar) March 15, 2024
Fashion has become a larger part of pop culture and Internet culture. Everyone and their mother knows the Met Gala and Fashion Week. pic.twitter.com/1dGbK3xZMb
Strano a dirsi, ma il modello seguito da Phoebe Philo possiede una freschezza tutta nuova, un tipo di riduzionismo che riporta il pubblico all’essenza del business che brand e clienti finali stanno conducendo: vendere e comprare vestiti. Con in più l’idea di farlo da un piccolo business (il brand di Philo ha appena un centinaio di dipendenti) che non si affida ai loghi, che conduce un’operazione più semplice e dunque più genuina. Come nel caso delle Olsen, un semplice ma significativo cambio di prospettiva che, in effetti, rende certe produzioni faraoniche della fashion week di Parigi tanto più spettacolari e grandiose quanto più occasionali ed estemporanee, memorabili per la mole della produzione e meno per la loro portata emotiva. Si farebbe meglio, come ha fatto Galliano da Margiela, creare uno show come una pièce teatrale senza volersi nemmeno immischiare con il pop – in quel caso, la sfilata come performance artistica pura regge ancora benissimo. Ma chi ne fa più? «Sento che [lo storytelling, ndr] non è necessario», ha detto Philo a Vanessa Friedman. «In una certa misura un brand ti piace o non ti piace. Qualcuno che mi racconta una storia non me lo farà piacere di più. È un cappotto. È un paio di pantaloni. Apprezzo un certo livello di franchezza». Un tipo di schiettezza che regna anche da Celine: l’offerta del brand è asciutta ed essenziale, l’enfasi è su capi quotidiani – lavorando, come Slimane fa, su pochi pezzi molto classici e ben eseguiti, con ovviamente il capo logato de rigueur, organizzare un intero show per presentarli è quasi superfluo, meglio inquadrarli in un agile videoclip il cui format consenta anche di lanciare nuove categorie di prodotto come capitato alla linea beauty che, infatti, ha ricevuto tutta l’attenzione prevista, senza impantanarsi dell’inferno logistico di una vera sfilata.
Ovviamente uno show rappresenta ancora un rito di passaggio fondamentale per un brand: poter sfilare nella cornice della fashion week rimane un privilegio e un battesimo del fuoco per moltissimi designer che cercano una propria legittimità. Hedi Slimane, Phoebe Philo e lo stesso Glenn Martens possono permettersi di non sfilare precisamente perché hanno costruito la propria fama sulle sfilate – e dunque diversi designer che desiderano di posizionarsi nella sfera della moda di lusso avvertono la necessità di presenziare alla fashion week. Le Olsen ad esempio sono tornate a sfilare a Parigi proprio per elevare il proprio brand, decidere di non mostrare la sfilata non ne elimina il ruolo ma lo riporta (un po’ come il modello di business di Philo) dentro una dimensione più onesta, meno adulterata dallo show-off dei social media. Potremmo dunque dire, parafrasando Churchill, che quello della sfilata è il format peggiore che abbiamo ma non ne conosciamo di migliori. Eppure sono tanti i brand, più o meno stabiliti, che di sfilate non vogliono sentirne parlare: Brunello Cucinelli preferisce da sempre l’atmosfera conviviale delle presentazioni nell’ambiente quasi domestico del proprio showroom; Our Legacy pubblica lookbook stagionali che sono meglio di tante sfilaten ma che, curiosamente, ne riproducono lo stile quasi a simularne una come a dire che bastano le foto ex-post, non l'evento vero; diversi brand di culto di successo poi come Heaven by Marc Jacobs, Stoffa, Howlin’, Percival, The Elder Statesman, ERL e Stussy non si curano degli show ma sono conosciuti e apprezzati tra gli insider dell’industria; altri come Marséll, Camper o Hereu si dedicano a precise categorie di prodotto affidandosi al fascino eterno del “If you know, you know” senza volersi necessariamente espandere.
@theoverview__ Our Legacy Fall 24 #fyp #fashion #ourlegacy #womensfashion #runway #viralvideo #milan drowning (edit) - Antent & vowl.
In tutti questi casi è un’estetica distintiva e un prodotto dalla grande qualità a supportare le vendite – ma più che le vendite, è a quel senso di attualità e di coerenza e continuità qualitativa che ci si dovrebbe riferire e che fa tornare i clienti. Forse ci sono anche abiti e brand estremamente cool che, messi in passerella, non parrebbero speciali abbastanza – e tutto questo perché proprio in questi anni ci domandiamo davvero a cosa serva una passerella, se a vendere un sogno, o a presentare una visione creativa che poi si trasferirà su collezioni più commerciali, oppure ancora a manifestare la grandezza del potere di spesa di un certo brand. Ma a questo punto è ormai chiaro che il successo di un brand non è correlato necessariamente alla presenza o meno di sfilate e che, per farcela, culturalmente parlando, non a tutti i brand serve davvero un posto in fashion week. I veri ingredienti del successo, in fin dei conti, rimangono ancora oggi uno stile autentico e un prodotto anche semplice ma altamente desiderabile.