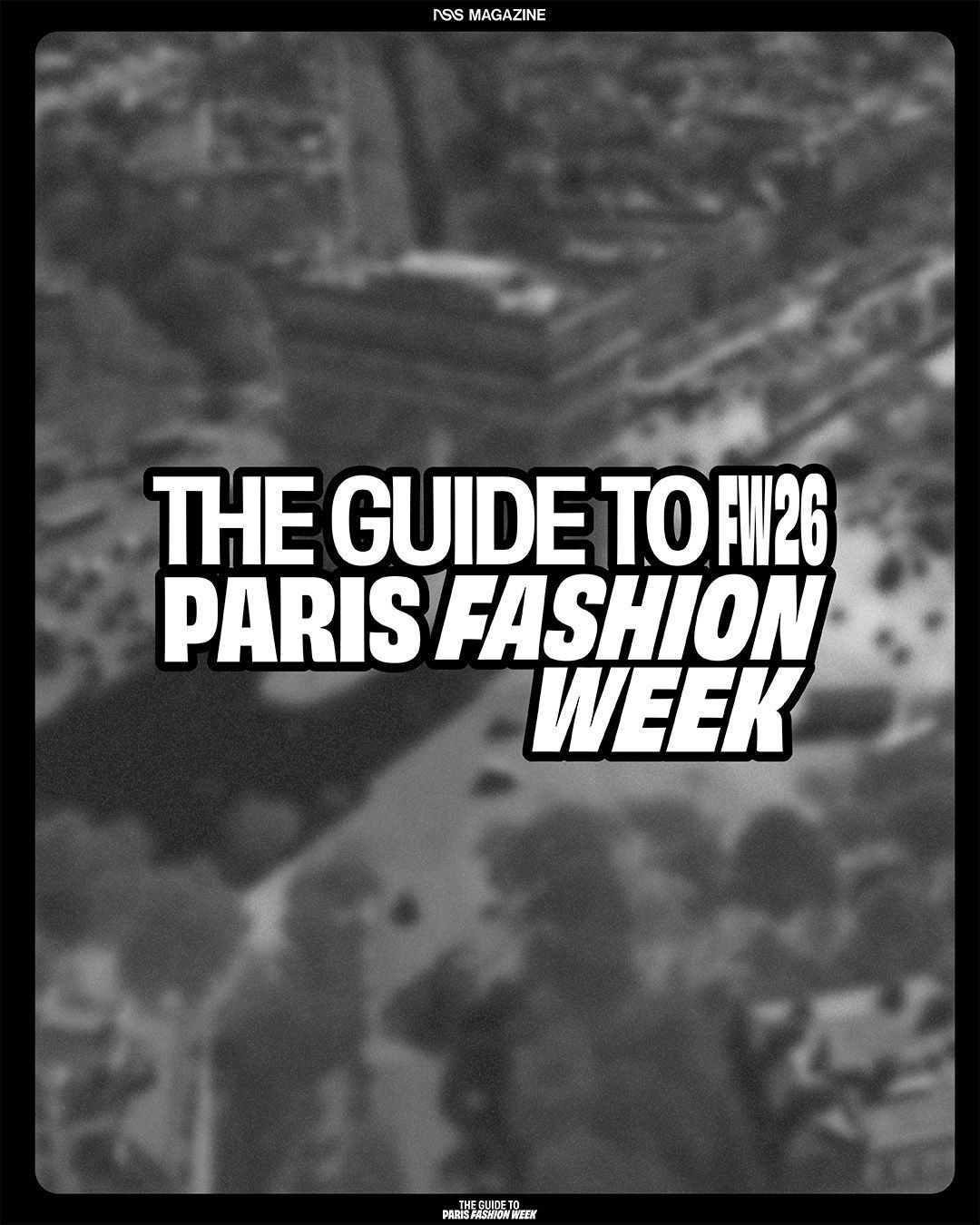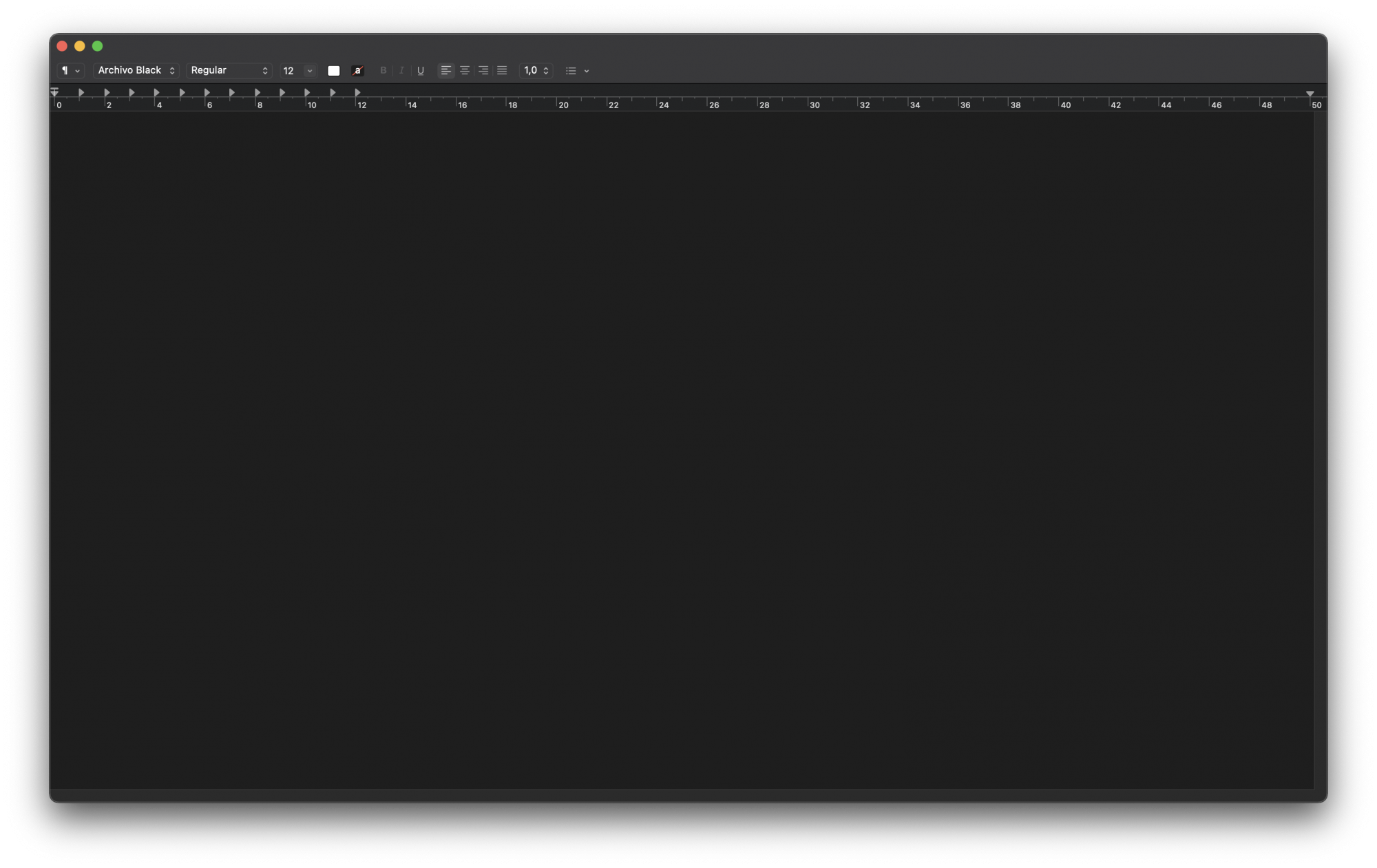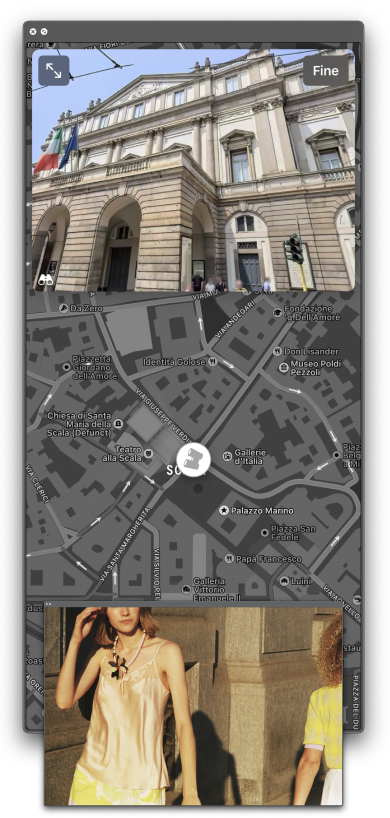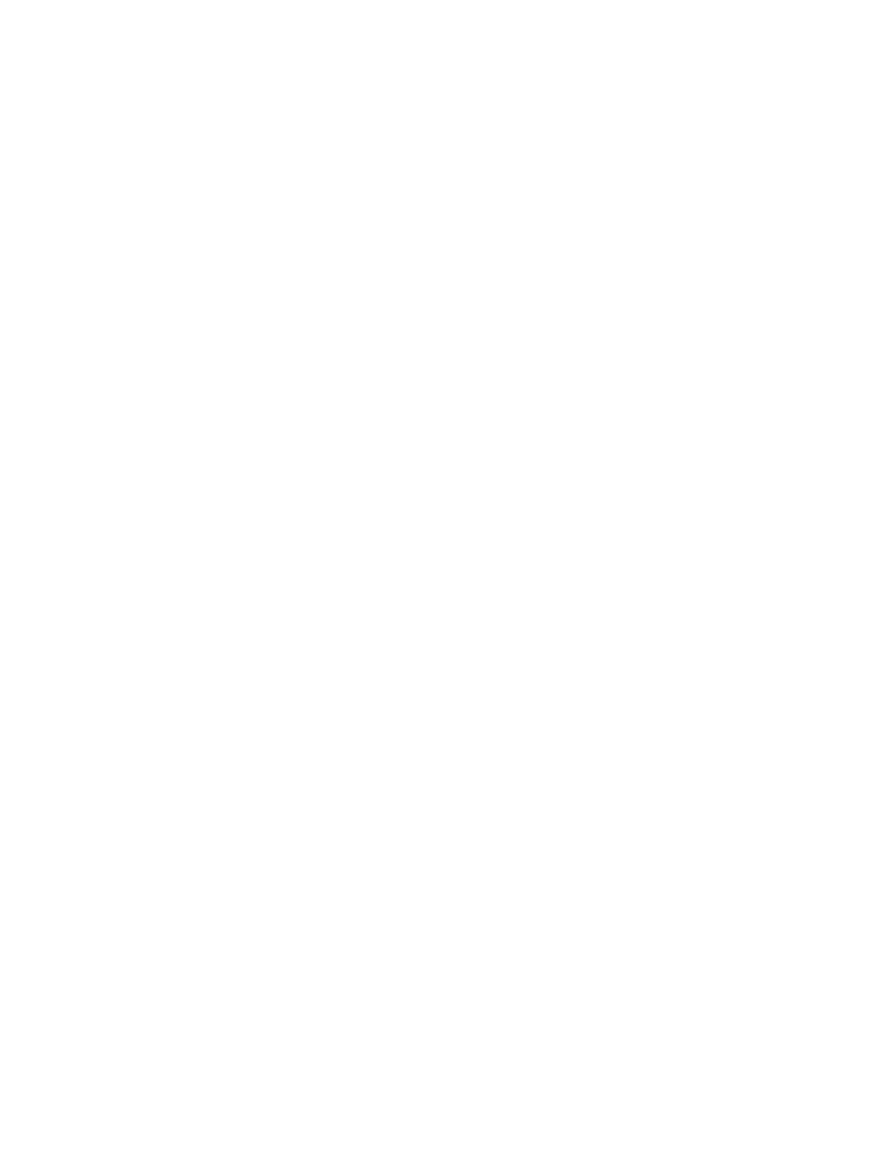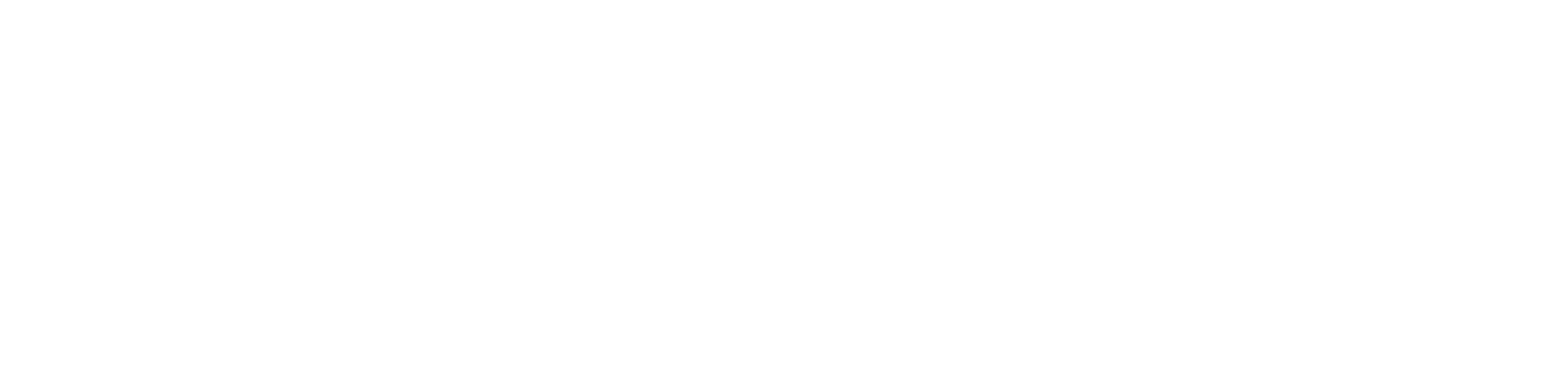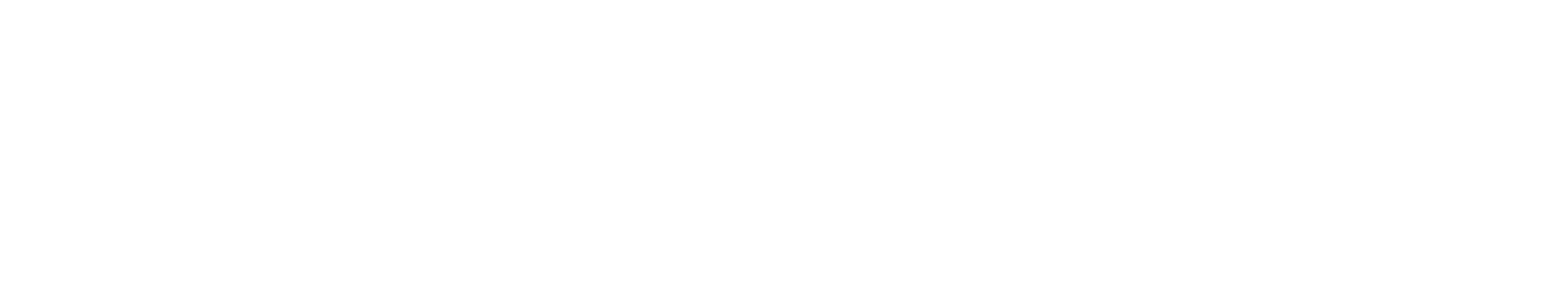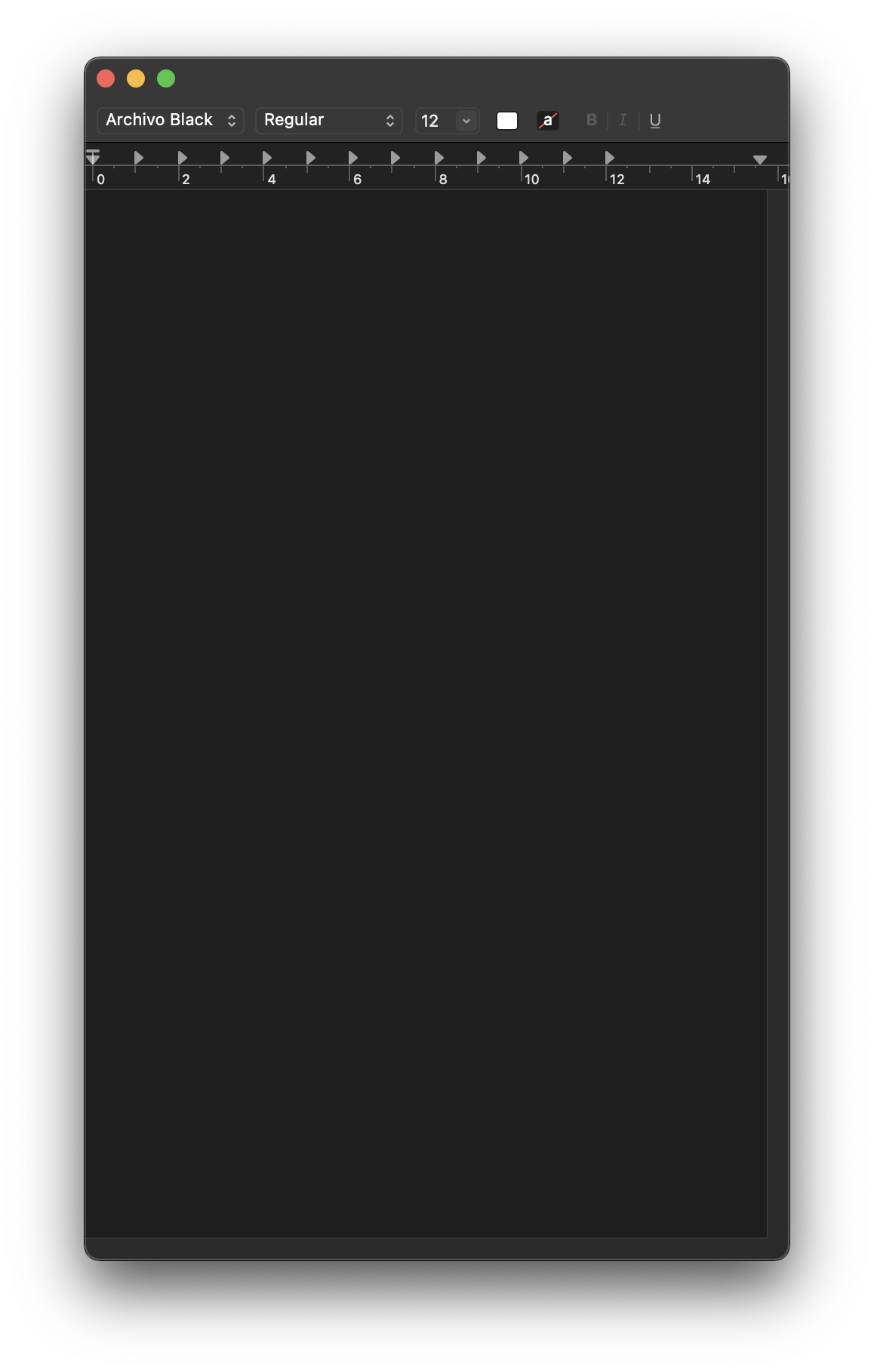L’archivio italiano: moda di un futuro passato NSS
L’archivio italiano: moda di un futuro passato
Quando la consapevolezza che una cosa di nome “archival fashion” si affacciò nella coscienza collettiva dell’industria, poco prima della pandemia, a molti appassionati di moda parve di avere trovato un nuovo scopo di vita. Cercare, acquistare e apprezzare i capi d’archivio portava la passione della moda al di là delle ultime passerelle e delle riviste patinate conferendole uno spessore intellettuale e per certi versi antiquario fino ad allora inedito. L’archivio era un antidoto alla genericità del branding contemporaneo che tutto annulla con la superficialità del proprio fascino e se dall’altro lato dell’oceano i primi archivisti collezionavano i migliori pezzi di designer come Jean-Paul Gaultier, Raf Simons, Ann Demeulemeester, Carol Christian Poell, Helmut Lang e Takahiro Miyashita, da questo lato dell’oceano, e nello specifico qui in Italia, sorgeva un dubbio: dove collocare l’enorme patrimonio del vintage italiano nell’universo della “archival fashion”? Tra mercatini e negozi vintage le vecchie creazioni dei grandi brand italiani con le loro moltissime linee di diffusione il materiale da catalogare e, spesso, da scartare è enorme. Non di meno pagine come @archived, @archivereloaded, @inside.tag, @lost.garments e @constantpractice hanno iniziato a fare una propria selezione con pezzi della collezione FW03 di Dolce & Gabbana, pantaloni e giacche di Emporio Armani degli anni ’80, grail del Prada anni ’90 e design di Massimo Osti e Mandarina Duck solo per citarne alcuni. Al di là della moda d’ispirazione più tattica invece sulle piattaforme secondhand le camicie in seta di Gianni Versace sono ancora vendute a migliaia di euro mentre i completi vintage della mainline di Giorgio Armani, quelli un po’ oversize e così simili a tuniche, sono stati molto ricercati.
Ma cosa rende un certo abito firmato da un designer italiano “d’archivio”? Interpellato a riguardo il giornalista indipendente Odunayo Ojo dice che «l’archivio è il vintage che viene ricercato» stabilendo come sue caratteristiche imprescindibili la presenza di una curatela e dunque di un filtro critico che distingue da ciò che è vintage e ciò che è archiviabile; la rilevanza storica del capo e i suoi eventuali sottotesti simbolici. In generale, l’esistenza di un archivio presuppone quella di un archivista e il valore di un certo capo non può prescindere dal senso critico di chi lo seleziona in mezzo al resto degli altri prodotti. Secondo Zeke Hemme, invece, founder di Constant Practice, piattaforma sulla quale appaiono spesso pezzi di Emporio Armani, Massimo Osti e Mandarina Duck non esistono pezzi “archival” e pezzi che non lo sono – esiste solo il design vintage. E a questo punto la questione sta nel determinare in che maniera quel design sia invecchiato: se un design anni ’80 è ancora desiderabile oggi, se ci dice ancora qualcosa e non trasmette un’idea di vecchiume allora siamo di fronte a un pezzo degno di essere indossato e apprezzato. Per quanto rigidamente pratico sia questo punto di vista, di fronte al mare magnum del vintage italiano, con tutte le sue sub-label e la sua smania di licenze commerciali che intorbidano le acque, questo tipo di concretezza servirà da strumento dirimente.
Prendiamo ad esempio il caso di Gianfranco Ferrè: couturier illustre che portò veri e propri capolavori in passerella, ma anche titano commerciale che concesse quattordici diverse licenze per il suo brand, con un numero enorme di linee di diffusione, facendo stampare il suo nome e il suo monogramma su un numero abnorme di trascurabili t-shirt, borsette e cappelli di lana. Distinguere la proverbiale pula dal grano non è semplice come distinguere tra mainline e linee di diffusione dato che, nel caso delle seconde per esempio, non mancano esempi di prodotti basic ma di altissima qualità. Lo stesso potrebbe dirsi di molte delle linee “Jeans” che Versace, Armani, Trussardi e Valentino produssero negli anni ‘80 ma anche, uscendo dal reame delle grandi griffe, di molto di quel vintage che si trova nei mercatini, costituito da brand come Rifle Jeans, El Charro, Carrera e Facis per citare i più comuni che rappresentano esempi illustri di un Made in Italy solidissimo, parte della cultura pop di qualche decennio fa, ma che oggi è ingiustamente dimenticato. Troppo spesso capita, infatti, che siano proprio pagine estere a dare legittimità all’archivio di grandi brand: eccettuati i design di brand illustri da sempre come Fendi, Gucci o Prada, la già citata collezione FW03 di Dolce & Gabbana, così come le creazioni dei primi 2000 di Roberto Cavalli e i tesori iper-funzionali di Emporio Armani e di C.P. Company sono state tutte scoperte portate di fronte a una platea internazionale da archivisti internazionali. Eppure la “messa a sistema” del vintage italiano, la sua suddivisione e catalogazione avrebbero bisogno di archivisti italiani presenti sul territorio in grado di riconoscere i prodotti alti, medi e bassi di questa galassia e di selezionarne i design in un insieme, se non coerente, almeno completo. Ciò che manca in Italia, insomma, non è tanto la presenza materiale di abiti vintage quanto più gli archivisti che facciano nel nostro paese lo stesso tipo di lavoro che le pagine inglesi o americane menzionate sopra fanno nei propri. Il che implica un processo di ricerca e documentazione per nulla facile da un lato, e dall’altro un’opera di convincimento nei confronti del pubblico italiano che potrebbe essere sia restio a ricercare e apprezzare abiti firmati da designer di cui oggi si sente parlare poco, sia a investire somme di denaro importanti in pezzi d’epoca di grandi marchi dall’appeal meno immediatamente commerciale. L’esperimento dell’archivio, comunque, così come lo hanno messo in pratica quest’anno Gucci con il progetto Vault e Valentino con il progetto Vintage sembra non solo riuscito, ma anche in attesa di qualcuno che lo metta in atto.