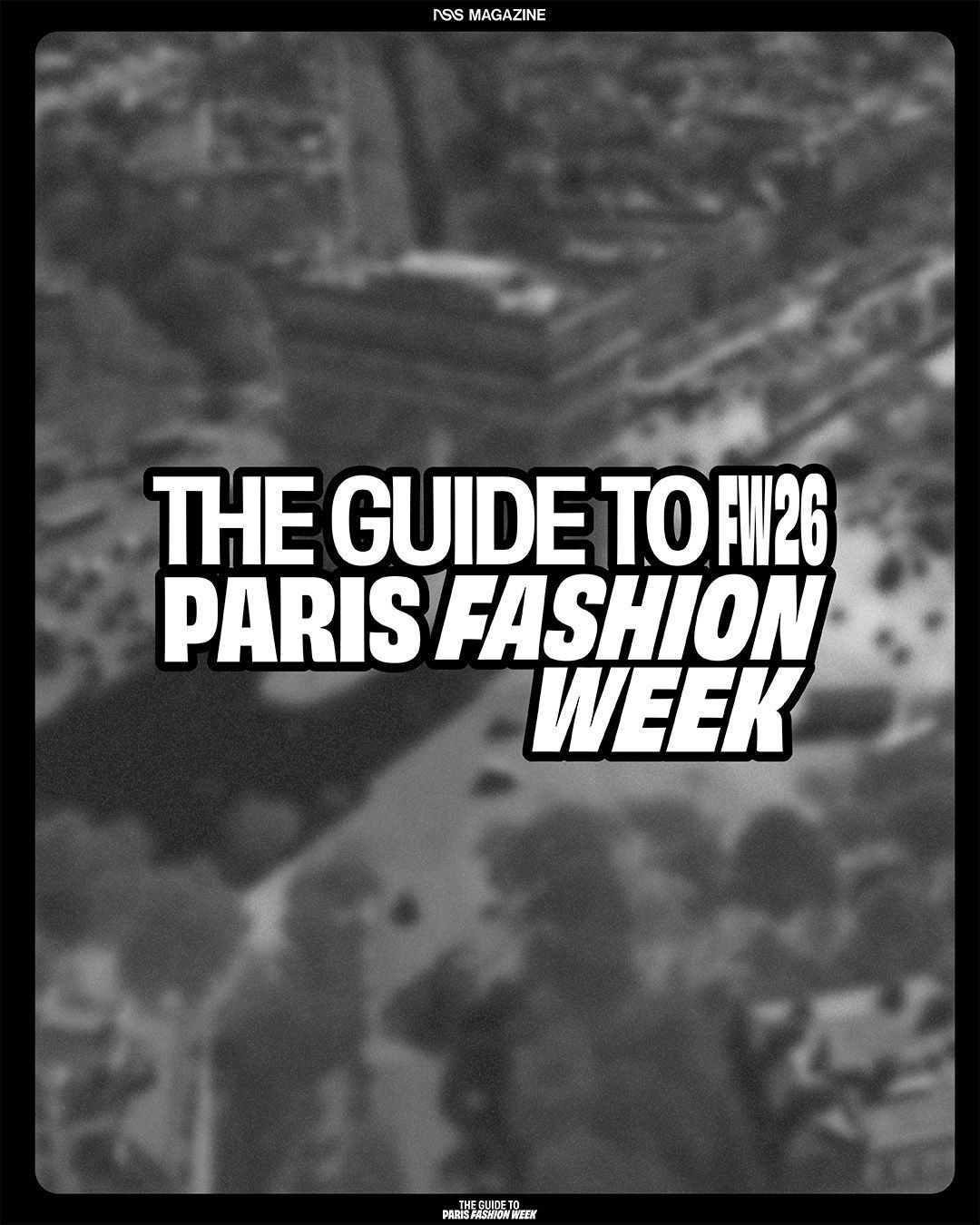Come il fenomeno di “Non è la Rai” anticipò TikTok di trent’anni Un’idea di televisione nuova, che inaugurò una nuova epoca
Se sui social il ventennio di Berlusconi in Italia è diventato fonte di meme ironico-nostalgici, i Millennial (che all’epoca erano solo bambini) ricordano ancora il clima che si respirava in quegli anni. Un clima che è stato catturato sullo schermo da film come Loro di Sorrentino e Il Caimano di Moretti, dall’intero corpus cinematografico dei fratelli Vanzina o dalla miniserie storico-noir 1992 che romanza la storia di Tangentopoli e ha Berlusconi tra i suoi protagonisti. Al di là della politica vera e propria, infatti, Berlusconi fece sentire la propria presenza nel paese attraverso i mass media e la televisione: sua fu l’epoca degli anime e de I Simpson trasmessi all’ora di pranzo, di Striscia La Notizia e delle veline, di Mike Bongiorno, delle miniserie di Lamberto Bava, de Il Grande Fratello e Uomini e Donne. Un’epoca televisiva di eccesso e frivolezza che iniziò, forse ufficiosamente, con un programma apparentemente leggero ma che lasciò un impatto indelebile nella cultura pop del paese e che, tra le altre cose, riuscì ad anticipare di molto i social media e nello specifico TikTok grazie alle peculiarità di un format basato quasi solo su spontaneità e improvvisazione – questo programma era Non è la Rai. A trent’anni dalla fine della trasmissione, considerando il vasto panorama della televisione italiana degli anni '90, pochi programmi sono riusciti a catalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica, a dividere in modo netto spettatori, critici e intellettuali, e a rappresentare in maniera così iconica un’intera fase culturale come Non è la Rai. «Oggi va ancora in onda», ci ha detto Irene Ghergo, una delle autrici del programma che abbiamo intervistato, «è ancora moderno, non è invecchiato». E per comprendere appieno la genesi e l’impatto di questo fenomeno mediatico, è necessario partire da colui che lo ha ideato: Gianni Boncompagni, un innovatore, provocatore, autore geniale e controverso, che ha saputo leggere e anticipare i cambiamenti della società italiana, trasformandoli in spettacolo televisivo.
@atlaskaneyt Ultima puntata non è la Rai 1995 Ambra Angiolini ultima in lacrime #trash #anni90 #mediaset #storia #amore All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey
Nato ad Arezzo nel ’32, da padre militare e madre casalinga, visse a Stoccolma dai 18 ai 28 anni, studiò grafica e fotografia, lavorò in radio e metterà anche su famiglia. Al suo rientro in Italia nei primi anni ’60, partecipa e vince un concorso Rai per programmatori musicali avviando la sua carriera nella radiofonia pubblica, dove impone da subito un nuovo linguaggio, più fresco, diretto e giovanile. In coppia con Renzo Arbore, nel 1965 dà vita ai programmi cult Bandiera Gialla e ad Alto Gradimento prima di iniziare a lavorare in televisione nel ’77 con Discoring, seguito nel 1980 da Superstar e poi dal leggendario Pronto, Raffaella? con Raffaella Carrà, il primo programma televisivo italiano a introdurre nel 1983 i giochi telefonici in diretta – una rivoluzione che portò il programma a toccare picchi di ascolto inauditi, superando i 9 milioni di telespettatori. Quando la Carrà lasciò il programma, Boncompagni continuò ma ricevette, a inizio anni ’90, un’offerta da Silvio Berlusconi che voleva portare questo moneymaker sulle reti Fininvest. «Berlusconi aveva capito e diede carta bianca», ci dice Irene Ghergo. «Era un visionario e diede a Gianni fiducia a un concetto che altrove non sarebbe passato. E infatti la tv paillettata, scosciata è subito sembrata vecchia». L’idea iniziale era replicare il format di Pronto, Raffaella? ma poi viene messa di lato – serviva nuovo prodotto che riuscisse a raccontare la nuova società dei consumi, post-boom economico che prendeva forma in Italia. Fu così che Boncompagni concepì l’idea di un programma senza ambizioni pedagogiche, culturali o educative della tv pubblica, «del tutto estemporaneo, senza sceneggiatura, basato sul talento naturale», come racconta Ghergo. Un programma capace di catturare l’attenzione di una nuova categoria di consumatori che si affacciava sul mercato: i teenager. Era nato Non è la Rai.
Ironico e irriverente già dal titolo, in aperta opposizione alla televisione delle paillettes, degli abiti da sera e dei capelli cotonati e «del pubblico marmorizzato» come lo definisce Ghergo. La prima puntata di Non è la Rai andò in onda nel settembre del 1991 su Canale 5, a mezzogiorno. Alla conduzione ci sono Enrica Bonaccorti, Antonella Elia e Yvonne Sciò. Nello studio di Centro Safa Palatino a Roma si alternano oltre 100 ragazze tra i 13 e i 19 anni («ruspanti», le definisce Ghergo) che ballano, cantano in playback e partecipano a giochi telefonici. «Non era un formato di grandi ascolti ma era rivoluzionario», ricorda Ghergo. L’ambientazione era una scenografia con le quattro stagioni dove le ragazze si esibivano a rotazione «facendo parte di canti e di balletti all’impronta». Il format ha qualcosa di totalmente nuovo: un’energia caotica, quasi psichedelica, data dall’interazione fra decine di teenager esuberanti, dal ritmo frenetico e dalla regia ipercinetica di Boncompagni, che dirige con una precisione chirurgica, spesso parlando direttamente alle ragazze tramite auricolari. Il programma ha successo, viene rinnovato. Nel ’92, con la seconda stagione, il programma arriva nel primo pomeriggio su Italia 1, giusto in tempo per essere visto al ritorno dalla scuola, e alla conduzione arriva Paolo Bonolis mentre la scenografia si trasforma in un’isola tropicale con piscine, palme e sabbia. Le ragazze non sono più semplici comparse: diventano le protagoniste assolute. Nel ‘93, arrivò ciò che Ghergo definisce «la grande rivoluzione», Ambra Angiolini, «una ragazza timidissima, introversa che Boncompagni individuò subito durante un mega-provino per Bulli e Pupe» che non solo diventa la conduttrice e il volto del programma ma un fenomeno pop, adorata dai giovani e odiata dagli adulti. «Si è dimostrata una fuoriclasse e lo è sempre rimasta», dice Ghergo. Tramite auricolare («i conduttori non lo sopportano, è difficile parlare con qualcuno che ti parla nell’orecchio», ricorda Ghergo), Boncompagni le suggerisce battute, commenti e perfino dichiarazioni politiche. Celebre l’episodio in cui Ambra afferma, in piena campagna elettorale, che “Dio vota Berlusconi”, mentre “Satana vota Occhetto”, suscitando un putiferio politico-mediatico. Ambra diventa anche cantante: il suo brano T’appartengo, scritto e prodotto da Boncompagni, raggiunge la vetta delle classifiche italiane e conquista quattro dischi di platino, diventando colonna sonora di una generazione.
Come sempre, in Italia, non si può avere un po’ di successo senza disturbare associazioni di genitori, gruppi cattolici e moralisti assortiti. Non è la Rai finisce nel mirino di tutti i soliti sospetti: Famiglia Cristiana, il Telefono Azzurro, gli intellettuali di sinistra, Umberto Eco, le femministe e le associazioni per la tutela dei minori che lo accusano di sessualizzare le ragazze, di oggettificarle dati i costumi oggi innocui ma all’epoca colpevoli di lasciar vedere le gambe o l’ombelico delle giovani protagoniste. «La cosa ci lasciò indifferenti», dice Ghergo e infatti Boncompagni risponderà sempre con sarcasmo, raddoppiando la provocazione: scrive la sigla Affatto deluse in cui le ragazze vestite da spose ironizzano sulle accuse ricevute e la canzone Non sono Lolita. Eppure la produzione del programma non potrebbe essere più innocua: «le ragazze dovevano rispettare regole rigorose: nessun trucco da soubrette, indossavano gli short sotto le gonne, i genitori erano sempre presenti e dovevano vestirsi come si sarebbero vestite nella loro vita», ricorda Ghergo. Nel frattempo, mentre i moralisti infuriano, all’esterno degli studi Safa Palatino, centinaia di fan si accalcano per vedere le ragazze uscire. «La quantità di posta che arrivava…», ci dice Ghergo. «Migliaia e migliaia di lettere». Si forma un vero e proprio culto di massa attorno al programma, con riviste, calendari, cd, fan club ufficiali e merchandising. La trasmissione è talmente potente da influenzare la moda, il linguaggio e i comportamenti dei teenager italiani. Le ragazze di tutta Italia imitano i look, i balletti e perfino i modi di parlare delle protagoniste di Non è la Rai. Fu a quest’altezza temporale che ci fu l’iconico episodio dell’Eternit, rimasto negli annali del trash italiano. «Non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia» è una frase forse poco meno celebre di «Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno». Lo show aveva saltato lo squalo: nel ‘95, dopo quattro stagioni e centinaia di puntate, Boncompagni decide di chiudere il programma con un’ultima stagione meno incisiva, più patinata e meno provocatoria. «Venne interrotto perché si era esaurito l’entusiasmo», ci dice Ghergo. «Tornò in Rai a sviluppare Macao». Ma anni dopo, quegli stessi elementi fondamentali, quella ricetta quasi perfetta di un contenuto così leggero da avvicinarsi al vuoto pneumatico tornò sotto forma di TikTok: i parallelismi tra i due fenomeni sono sconcertanti.
Ambra Angiolini - T'appartengo (Live at Non è la RAI, 1994) pic.twitter.com/9ZjQDLtupE
— e (@muddytrap) February 22, 2018
Il paragone tra Non è la Rai e TikTok non è banale: entrambi si fondano su un format non-scripted che mette i giovani al centro, alimentati da uno tsunami di sciocchezze, irriverenza, trash e, in parallelo, scandalo. Ma è proprio in questo mix caotico che nasce il loro potere culturale, la capacità di creare fenomeni generazionali che scuotono l’opinione pubblica e fanno infuriare i puristi. In quel settembre 1991, Non è la Rai arrivò come un fulmine a ciel sereno: uno show antitetico alla Rai, costruito su moduli brevi, diretta live, centinaia di adolescenti in playback, giochi telefonici e una regia che mercava sull’imperfezione, sull’improvvisazione. Così come oggi TikTok genera interesse ed engagement grazie ai video brevi, spesso confusi, dal montaggio rapido, dove la sciocchezza diventa linguaggio e chiunque può emergere come una personalità virale – pensiamo ad esempio al “very demure, very mindful” di Jools Lebron. Entrambi spingono i giovani a partecipare, a stacreare ciò che oggi definiamo engagement, a creare uno show in cui il valore non nel contenuto rigoroso, ma nella performance immediata. Il cuore pulsante è sempre lo stesso: la partecipazione giovanile e collettiva. In tv, le ragazze di Boncompagni respiravano eccitazione simile a quella dei TikToker della Gen Z c e le “camerette” di TikTok sono le antenate di quegli studi del Safa Palatino: luoghi di microfama, dove bastano pochi secondi per diventare visibili, imitati, invidiati. Ancora oggi, un balletto goffo in playback ricorda il caos danzante di quelle mattinate in diretta.
Un importante aspetto che avvicina i due fenomeni è il carattere unscripted, irriverente, spontaneo. Boncompagni aveva capito che un montaggio caotico, inquadrature aeree, errori, sentimenti forti, potevano generare identità collettiva grazie al loro realismo immediato. TikTok fa lo stesso: video brevi, rumori forti, coreografie improvvisate e parlato da “vernacolo” diventano stile. Il caos è contenuto, ma rappresenta la lingua parlata di una generazione che non vuole studiare, ma esibire. Scivola verso il trash, è vero, ma proprio quel disvalore trasforma il tutto in valore, come si leggeva nei nostri scambi passati: “il nulla elevato ad arte”. Questo “nulla” ha portato a espressioni di panico morale che rispecchiano perfettamente ciò che accadde all’epoca. Oggi, TikTok viene accusato di produrre dipendenza, disturbi dell’attenzione, problemi di autostima, di spingere alla iper-sessualizzazione delle adolescenti, si invoca la protezione dei minori contro “il male assoluto” come furono, nei decenni passati, il rock’n’roll, gli anime o videogame. Eppure, come dicevano gli studiosi: la panico è ciclico, i bambini percepiti come “innocenti” devono essere protetti, mentre l’innovazione mediatica diventa capro espiatorio. Per la tv dei primi anni ’90 era il playback irriverente e le ragazzine urlanti, per il 2025 è l’algoritmo visivo senza filtro.
Quando dite "io a 14 anni giocavo ancora con le bambole" per sottolineare la presunta spregiudicatezza delle ragazzine contemporanee rispetto alla vostra antica pudicizia mi chiedo se per caso avevate 14 anni nel 1920. No, perché 30 anni fa c'era Non è la Rai. Per dire.
— Letizia Pezzali (@letipezz) April 28, 2025
Passando al discorso della soggettività, sia Non è la Rai che TikTok creano una forma nuova di rete sociale visiva: la prima era uno studio tv senza pubblico, un concentrato di energia adolescenziale. La seconda è un feed infinito, personalizzato da un algoritmo che costruisce una “flow experience” creando un senso di immersione, ma entrambi generano dipendenza e momenti di estasi collettiva. In tv si rimaneva incollati per vedere Ambra che dichiarava “Dio vota Berlusconi” o che introduceva Robbie Williams in studio: oggi quell’equivalente è il diario video con milioni di replay, memes e rimandi politici nel continuo scorrimento, con il gap che la notizia diventa microsecondo, e l’indignazione una funzione virale. Infine, entrambi i fenomeni furono produttori di momenti di cultura pop a volte effimeri, a volte durevoli ma comunque frutto di un simile veicolo di superficialità e sfruttabilità mediatica. Sia la televisione “non educativa” di Boncompagni e la social tv mobile di ByteDance hanno insomma segnalato la stessa tendenza: il passaggio dal consumo di contenuti strutturati a un flusso di frammenti, dalla regia cinematica alle scenografie domestiche, da un pubblico “igienizzato” a folle partecipazione giovanile. In entrambi i casi, lo spettacolo è costruito sull’influenza, il nonsense, il trash, l’appartenenza collettiva oltre che l’immancabile scandalo culturale. La differenza è che oggi lo vediamo tutti, ogni giorno in tasca. Un mix di incoscienza performativa, protagonismo giovanile e scandalo morale che hanno definito un fenomeno generazionale.